
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.
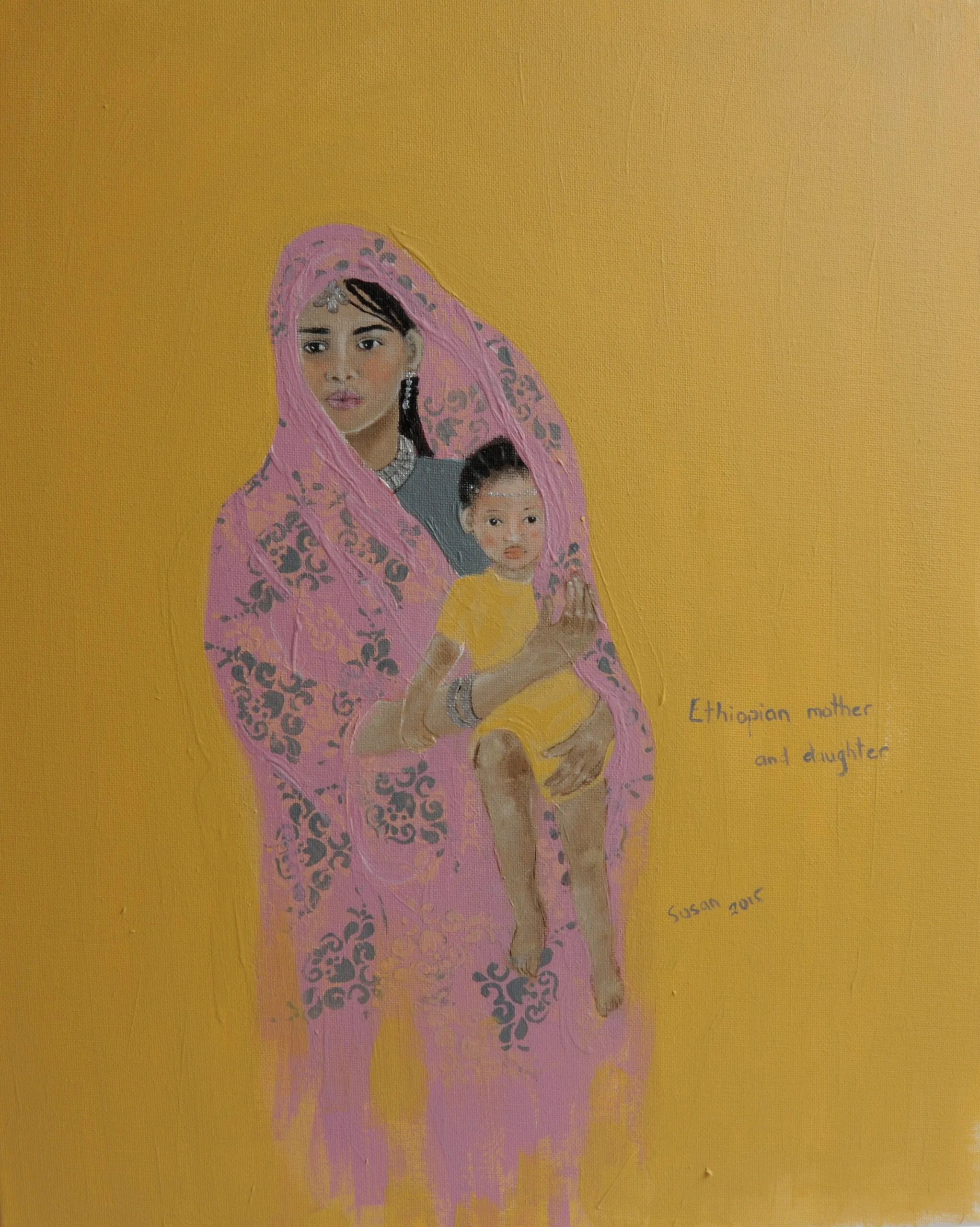
Roberto Beneduce Professore ordinario in discipline demoetnoantropologiche, Università degli Studi di Torino; fondatore del Centro Frantz Fanon.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Il ciclo di incontri avente come tema l’etnopsichiatria ha l’ambizione di offrire elementi introduttivi a un sapere complesso quanto controverso, la cui conoscenza, per i clinici (psichiatri, psicoterapeuti, psicologi), è andata crescendo progressivamente fino a imporsi come uno strumento imprescindibile nell’incontro con espressioni e idiomi della sofferenza e del disturbo psichiatrico con i quali si ha scarsa consuetudine.
Praticare l’etnopsichiatria in modo congruo e rigoroso richiede, però, oggi un triplice passo epistemologico: 1) acquisire piena consapevolezza delle radici storiche di un sapere nato nel contesto delle colonie; 2) esplorarne le rigogliose connessioni con altre discipline (la psicoanalisi, l’etnologia, l’antropologia simbolica, la linguistica, la storia delle religioni) per coglierne tutta la densità teorica; 3) pensare il suo sviluppo e la sua applicazione non solo in riferimento al ruolo della differenza culturale nell’interpretazione e nella cura dei disturbi psichici, ma anche per interrogare il rapporto costitutivo fra ordine sociale, malattia mentale e saperi della cura.
Questo ultimo aspetto ha una evidente ricaduta: “etnopsichiatria” non è solo “la psichiatria degli altri” ma la stessa psichiatria occidentale, le cui categorie diagnostiche, i cui strumenti terapeutici e i cui criteri di efficacia sono anch’essi – e non potrebbero non esserlo – culturali, ossia coerenti con un particolare orizzonte sociale e in dialogo con le inquietudini di un tempo e di una società particolari (non esiste dunque una psichiatria e una etnopsichiatria, dal momento che ogni psichiatria è sempre un’etnopsichiatria).
All’interno di questa prospettiva, dopo aver esplorato i concetti fondamentali e i pionieri di questo sapere, fra i quali spicca in Italia il nome di Ernesto de Martino, il corso indaga alcune delle principali scuole ed esperienze (quella di Fann-Dakar, ad esempio) nonché altri modelli di cura della malattia mentale (ciò che viene spesso definito nel suo insieme come il campo delle “medicine tradizionali”), per approdare poi all’etnopsichiatria della migrazione come al territorio che più ha consentito di misurare da un lato i limiti della psichiatria occidentale, dall’altro l’urgenza di immaginare una clinica in grado di confrontarsi con altre eziologie e altre semantiche del male.
Il corso prende in considerazione, nell’ultima parte, alcune recenti categorie diagnostiche (PTSD, sindrome della rassegnazione, solastalgia, ecoansia, ecc.) per analizzarne in chiave etnopsichiatrica i presupposti ideologici e i legami con le incertezze derivanti dalle politiche della cittadinanza o dalle minacce della crisi ambientale e climatica.
Tre lezioni a cura di Roberto Beneduce:
Che cosa è l’etnopsichiatria?
Etnopsichiatria e migrazione
Dalla critica del diagnosticismo alle promesse dell’eco-etnopsichiatria
Medico Chirurgo: Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore Professionale
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere
Assistente Sanitario
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Benedetto Farina Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università Europea di Roma (UER).
Alessandra Lemma Consulente presso l’Anna Freud National Centre for Children and Families.
Clara Mucci Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo.
Laura Muzi Ricercatrice in Psicologia Clinica presso il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Università degli Studi di Perugia.
Grazia Spitoni Professore associato, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma.
Vittorio Lingiardi Psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group).
Dal corpo non si scappa, il corpo è un tema trasversale e sempre contemporaneo. Nella sua presenza e ancor più nella sua assenza o nella distanza. Il corpo, che è uno solo, si moltiplica negli sguardi disciplinari e si ricompone nel loro incontro: è nel diritto e nella salute, nel linguaggio e nell’arte, nelle gender politics e nel fenomeno migratorio. È nell’esame del medico, obiettivo, istologico, radiografico. È nelle pratiche dello sport e nello studio dei neuroni specchio. È nell’esperienza della cura psichica, nella dimensione del trauma e nei disturbi del comportamento alimentare.
Le neuroscienze, soprattutto quando applicate all’indagine clinica, studiano le immagini e le rappresentazioni corporee, il concetto di u003cemu003eembodimentu003c/emu003e, l’affective touch e le realtà immersive.
Soprattutto per le generazioni più giovani, il corpo è sempre più un luogo della ricerca identitaria, soglia e limite tra interiorità e esteriorità. Un corpo da modificare anche radicalmente, da potenziare o esibire, su cui tracciare i segni di un dolore che non trova le parole. Un corpo che il diritto può riconoscere o disconoscere, a partire dalle vicende di libertà e relazione che in esso si incarnano. Il corpo è nelle tecnologie, nella moda dei tatuaggi e nelle sessualità. È nel tempo che passa. La pandemia Covid-19 ha messo una lente d’ingrandimento sui nostri corpi: la loro cura e la loro legislazione, il contatto e la distanza. Ascoltiamo i corpi e le loro storie: passate, presenti e future.
Nella sua dissertazione, psicoanalitica con elementi di sociologia e letteratura, Clara Mucci ripercorre la storia del corpo delle isteriche, da Freud a Lacan, per evidenziare l’immutata richiesta di affetto infantile, più che il richiamo sessuale, delle pazienti di ieri e di oggi. Chiedendosi che diversa valenza assuma, nella contemporaneità dei binarismi culturali messi in discussione, la questione del genere, della sessualità e del potere.
Grazia Spitoni dedica la sua lezione al contributo delle neuroscienze alla comprensione dei disturbi alimentari, in particolare nella differenza tra corpi rappresentati e corpi percepiti. Dopo una premessa storico scientifica, si analizzano le alterazioni anatomo-funzionali, i deficit cognitivi e la dicotomia tra immagine corporea e schema corporeo. Immaginando modelli meno condizionanti grazie all’onda social del “body positivity”.
Anoressia, bulimia, obesità, vigoressia, dismorfismo sono le forme del corpo che Laura Muzi analizza nella sua lezione sulla comprensione dei disturbi alimentari. Le definizioni e l’approccio diagnostico del DSM-5 e quello più centrato sull’individuo del PDM-2 fungono da base per scoprire anche le forme emergenti di pattern alimentari disfunzionali, come l’ortoressia nervosa, da affrontare anche in una prospettiva psicodinamica.
Citando casi raccolti anche nella sua esperienza clinica in carcere, Alessandra Lemma indaga le ragioni di modificazioni corporee quali tatuaggi, piercing, scarificazioni, interventi di chirurgia estetica. Manifestazioni di persone affette da patologie mentali delle quali i corpi raccontano le storie, segnate da abusi fisici ed emotivi. Ma pratiche ormai diffuse anche in chi vi simbolizza forme di empowerment, ribellione, autodeterminazione.
Nella sua lezione sui danni del corpo conseguenti ad esperienze traumatiche, Benedetto Farina sgombra il campo da interpretazioni simboliche della sofferenza psichica promosse per decenni dalla manualistica internazionale. Con esempi di casi clinici e citazioni letterarie e filmiche, nel solco della psicotraumatologia attuale si afferma l’evidenza patologica del dolore fisico legato ai traumi dello sviluppo.
Il corpo isterico: esiste ancora? Lezione di Clara Mucci
Le forme del corpo: anoressia, obesità, vigoressia, dismorfismo. Lezione di Laura Muzi e Grazia Spitoni
La pelle: piercing, tatuaggi e psoriasi. Lezione di Alessandra Lemma
Il corpo del trauma. Lezione di Benedetto Farina
Medico Chirurgo: Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore Professionale
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere
Assistente Sanitario
Benedetto Farina è Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università Europea di Roma. Vice coordinatore del corso di laurea magistrale in psicologia della UER. Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Psicologia dinamica e clinica” dell’Università Sapienza di Roma. È membro del Scientific Advisory Board dell’International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Socio didatta e membro del Direttivo della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, nonché socio ordinario dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), della European Society for Trauma and Dissociation, di EMDR Italia. E’ stato vincitore del Richard P. Kluft Award for Journal of Trauma and Dissociation 2015 Best Article.
Alessandra Lemma è Fellow della British Psychoanalytical Society e consulente presso l’Anna Freud National Centre for Children and Families del Regno Unito. Attualmente è Visiting Professor all’University College di Londra; è stata Visiting Professor all’Istituto Winnicott, all’Università Sapienza di Roma e al Centro Winnicot di Roma e Honorary Professor di Psychological Therapies presso la School of Health and Human Sciences, University of Essex. Per molti anni ha lavorato presso il Tavistock and Portman NHS Foundation Trust dove è stata, in momenti diversi, a capo della psicologia e docente di terapie psicologiche. È stata redattrice della serie di libri New Library of Psychoanalysis (Routledge) per dieci anni fino al 2020 ed è stata una delle redattrici regionali dell’International Journal of Psychoanalysis fino al 2018.
Clara Mucci è psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico e professore ordinario di Psicologia dinamica presso l’università di Bergamo, dove è Presidente del Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica. Fino al 2012 è stata ordinaria di Letteratura Inglese e teatro shakespeareano presso l’università di Chieti. Dopo la laurea in letteratura inglese ha proseguito gli studi (in letteratura e psicoanalisi) con un PhD in studi interdisciplinari presso l’Institute of Liberal Arts, Emory University, Atlanta, USA, e un dottorato in Anglistica presso l’università di Genova. Ha poi conseguito la laurea in Psicologia e la specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica a Milano (SIPP), dopo aver effettuato un tirocinio di sei mesi come Fellow di Psicologia presso l’Istituto per i Disturbi di Personalità diretto, a New York e a White Plains, NY, da Otto Kernberg. Ha conseguito il titolo per effettuare lo scoring della AAI (Adult Attachment Interview, per la scuola di Main e Hesse, Berkeley, Usa, sotto la guida di Jakobson, Dazzi e Speranza, e la RF (Reflective Functioning) con un training con Howard Steele, Co-Director, Center for Attachment Research, New School, New York. Ha scritto numerosi articoli e dieci monografie su letteratura e psicoanalisi, teorie della letteratura e scrittura al femminile, psicoanalisi e psicologia clinica. Tra i più recenti volumi in quest’ultimo settore, Trauma e perdono, 2014, Raffaello Cortina Editore, Corpi Borderline, Norton e Cortina, 2020, Resilience and Survival, Confer Books, London.
Laura Muzi è psicologa, dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica. Attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma.
Grazia Fernanda Spitoni è professore associato nel settore scientifico disciplinare M-PSI03; docente presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dei corsi di Data Analyses and statistical testing in cognitive neuroscience e di Disegni, Analisi dei dati e Statistica psicometrica nelle neuroscienze; presso scuola di specializzazione in Neuropsicologia e presso la scuola di dottorato in Neuroscienze del Comportamento dell’Università Sapienza di Roma. E’ membro della SINP (Società Italiana di Neuropsicologia); della SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva); della Npsa (The International Neuropsychoanalysis Society) e della IASAT (International Association for the Study of Affective Touch).
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Guido Giovanardi Ricercatore in Psicologia Dinamica presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma
Vittorio Lingiardi Psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)
Marianna Liotti Dottoranda in Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Gabriele Lo Buglio Dottorando e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma
Nancy McWilliams Psicologa clinica e psicoanalista, docente della Rutgers University (New Jersey, USA), autrice di testi psicoanalitici fondamentali e curatrice della seconda edizione del PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico). E’ stata presidente della Divisione di Psicoanalisi dell’American Psychological Association (APA)
Marta Mirabella Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma
Laura Muzi Ricercatrice in Psicologia Clinica presso il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Università degli Studi di Perugia
Vittorio Lingiardi Psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)
Nel suo ultimo libro “La supervisione. Teoria e pratica psicoanalitiche”, appena tradotto e pubblicato in Italia da Raffaello Cortina, Nancy McWilliams condensa la saggezza di una carriera consacrata all’attività clinica, alla scrittura saggistica, all’insegnamento e alla supervisione. Il testo, pensato e scritto per i clinici di ogni formazione e disciplina, ci introduce alla supervisione individuale e di gruppo, alla formazione in psicoanalisi e alle sue complesse problematiche etiche. Tenendo vivo il dialogo tra saggezza clinica e dati di ricerca, McWilliams approfondisce le dinamiche personali, le forme di diversità e gli equilibri di potere che possono caratterizzare la relazione di supervisione, risorsa cruciale nel percorso di crescita del clinico.
La supervisione, che per Freud è un’attività “educativa”, secondo l’Autrice rappresenta un modello di formazione ambizioso e intimo, dotato di obiettivi che non si esauriscono nella trasmissione di specifiche tecniche. McWilliams sottolinea come il lavoro di supervisore, rispetto a quello di terapeuta, richieda capacità di giudizio ancora più raffinate e particolari maturità e consapevolezza. Dalle origini freudiane, la pratica della supervisione ha cambiato volto e si è confrontata con molte teorie e diversi contributi, per esempio, i concetti di “alleanza di apprendimento” e di “processo parallelo”.
Come sempre, Nancy McWilliams, refrattaria a posizioni rigide e polarizzate, espone le sue idee e il suo lavoro con ampio respiro, sensibilità e saggezza clinica, fornendo consigli ai clinici in formazione e ponendo l’accento sui vari compiti dei supervisori, per esempio seguire i clinici più giovani nella formulazione del caso e nella verifica degli obiettivi della terapia.
Questo webinar si propone di approfondire non solo alcuni elementi chiave della supervisione clinica, ma anche di fornire una visione allargata e interdisciplinare, perché, dice McWilliams, “se una supervisione è buona, lo è indipendentemente dall’orientamento teorico del supervisore, del terapeuta o dal setting”.
La caratteristica unica di questo webinar è la presenza di giovani psicologi clinici e psicologhe cliniche, psicoterapeuti e psicoterapeute, chiamati a rivolgere a Nancy McWilliams i loro quesiti sui temi della supervisione. Così come nel volume che ha ispirato questo incontro il tema del dialogo e del confronto è vitale, anche questo webinar si configura come una possibilità di esplorazione interattiva e di colloquio su tematiche fondamentali legate alla supervisione. Questo webinar interattivo rappresenta inoltre la possibilità di assistere alla presentazione, alle intuizioni e alle argomentazioni “in presa diretta” di una grande terapeuta esperta in supervisione. Vittorio Lingiardi introdurrà i lavori.
È prevista traduzione simultanea.
18.00 – 18.10 Introduzione di Vittorio Lingiardi
18.10 – 18.30 Intervento di Nancy McWilliams
18.30 – 19.30 Domande di Guido Giovanardi, Marianna Liotti, Gabriele Lo Buglio, Marta Mirabella e Laura Muzi e risposte di Nancy McWilliams
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Il concetto di Sé in psicoterapia è oggi quanto mai impreciso, anche perché è usato da scuole diverse e ciascuna all’interno della propria teoria di riferimento. In questo seminario Paolo Migone spiega innanzitutto che il termine Sé può essere inteso in due modi molto diversi tra loro: il primo si riferisce al Sé come una “cosa”, una struttura con delle funzioni, potremmo dire alla mente di una persona (o alla persona stessa, alla sua personalità) e in questo caso si parla sempre in terza persona, può essere descritto o studiato con diverse modalità (ad esempio osservative o sperimentali); il secondo modo di intendere il Sé è invece soggettivo, cioè esperienziale, nel senso della rappresentazione che una persona ha di se stessa (ad esempio può avere una buona autostima, una certa idea o vissuto di sé, e così via).
A proposito del secondo modo di intendere il Sé, cioè come rappresentazione soggettiva di se stessi, bisogna però dire che per avere una rappresentazione di se stessi, per percepire un “senso di sé”, è necessario essere autocoscienti, avere l’autoconsapevolezza, cioè aver raggiunto un livello maturativo sufficiente. Nel caso del neonato ad esempio non si può parlare di questo tipo di Sé, perché occorre che abbia raggiunto almeno un anno e mezzo o due anni di vita, dato che nei primi mesi non è autocosciente. Naturalmente il neonato ha un Sé, ma si tratta per forza di un Sé inteso nella prima accezione, cioè di una mente dotata di un insieme di strutture e funzioni – anche molto sofisticate, che gli permettono per esempio di muoversi nell’ambiente e compiere azioni mirate – che però lo fanno assomigliare a questo riguardo agli animali, anch’essi estremamente abili ma senza autocoscienza (ad eccezione forse dello scimpanzé, il primate che più si avvicina all’uomo). Raggiunto un certo livello maturativo (e lo si può constatare, ad esempio, dalla capacità di riconoscersi allo specchio, e si noti che gli animali non sanno riconoscersi allo specchio), il bambino diventa gradualmente capace di rappresentare se stesso e quindi di possedere un Sé nella seconda accezione del termine, quella soggettiva o esperienziale. Dobbiamo quindi dire che coloro che utilizzano il termine Sé per un neonato in questa seconda accezione sbagliano, peccando di adultomorfismo. È invece del tutto giustificata l’espressione “Sé neonatale”, nel primo significato del termine, come struttura sottostante all’insieme delle funzioni mentali del bambino. 7, ad esempio, usa questo termine per descrivere le varie fasi della formazione del Sé nel bambino: “Sé emergente” (2 mesi), “Sé nucleare” (2-6 mesi), “Sé soggettivo” (8-18 mesi), “Sé verbale” (24 mesi). Non si può neppure dire, in senso dinamico, che il neonato abbia un Sé inconscio, perché il suo Sé (per forza inteso come un insieme di funzioni) non è mai stato rimosso (potremmo dire che è un Sé “non cosciente” nel senso che è tacito, implicito, procedurale, si tratta cioè di “inconscio cognitivo” e non di “inconscio psicoanalitico” o “dinamico” – su questo tema si veda il seminario di Paolo Migone su “L’inconscio psicoanalitico e l’inconscio cognitivo”). Possiamo parlare di un Sé inconscio solo dopo che il soggetto ha raggiunto quel livello maturativo che gli permette di avere una rappresentazione di sé ed eventualmente di rimuoverla (tra parentesi: in genere si scrive “Sé” con la iniziale maiuscola quando lo si usa come concetto, altrimenti si usa la minuscola). Ma possiamo fare questa ipotesi solo se aderiamo a una concezione psicodinamica e non strettamente fenomenologica, dato che gli approcci fenomenologici (e anche umanistici), prescindendo dal concetto di inconscio, in genere usano il termine Sé come rappresentazione conscia, sottovalutando così l’ipotesi – tipicamente psicoanalitica – che la coscienza possa basarsi su un autoinganno (Freud ad esempio diceva che “l’Io non è padrone in casa propria”, o che è una “marionetta”). In psicoanalisi possiamo ipotizzare che il paziente si difenda dall’essere pienamente consapevole di certe immagini di sé, ad esempio può negare una rappresentazione negativa di sé perché dolorosa, e grazie alla psicoterapia che lo rende più forte e sicuro può fare a meno di certe sue difese “narcisistiche” e ammettere di avere debolezze che prima negava. Tipicamente in psicoterapia noi lavoriamo su questo Sé, cioè sul modo con cui il paziente rappresenta se stesso, con cui “si vive”: può essere depresso oppure felice, può avere una bassa autostima, sentirsi svuotato, spento, vivo, eccitato, entusiasta, e così via, oppure può sentirsi confuso, avere idee contraddittorie di sé, caotiche, incoerenti, etc. Queste immagini che il paziente ha di sé sono l’oggetto della nostra attenzione terapeutica, e cerchiamo di aiutare il paziente a ordinarle, a dare loro un senso, eventualmente a fare a meno di certe difese nel caso ci sembri che le utilizzi, affinché arrivi a una maggior autenticità e congruenza con il suo mondo interiore.
Come si diceva, l’idea che una persona possa avere un’immagine di sé non vera, cioè che possa difendersi da un’altra idea di sé rimuovendola, è tipicamente psicoanalitica e si riferisce a un concetto che è sempre stato centrale in psicoanalisi, quello di conflitto, e precisamente di conflitto intrapsichico (non di conflitto esterno, cioè tra sé e il mondo esterno, perché questo è un discorso diverso, che non caratterizza la psicoanalisi in senso stretto o “classica” ma la psicoanalisi interpersonale o relazionale, che non a caso trova congeniale l’uso del termine Sé). Freud per cercare di descrivere il conflitto psichico aveva coniato dei termini che sono diventati molto conosciuti e che hanno caratterizzato la seconda topica (detta anche teoria strutturale o tripartita), e cioè Es, Io e Super-Io, e non a caso Freud non parlava mai di Sé (a volte ha utilizzato questo termine, ma in modo intercambiabile con quello di Io). Freud cioè voleva descrivere nel modo più chiaro possibile le istanze (le strutture) che dividevano la psiche caratterizzandole per il tipo di motivazione che avevano: l’Es voleva essere la parte istintuale, “animale”, pulsionale, di ciascuno di noi, che a volte deve essere controllata o regolata; l’Io voleva essere la parte razionale, il centro della persona, che si difende dall’Es e che regola i rapporti con la realtà esterna e anche con la forza del Super-Io; il Super-Io (che di fatto può essere visto come una provincia dell’Io) voleva rappresentare i valori che ci guidano, che a volte possono entrare in conflitto con l’Io e certamente con l’Es, e che possono essere anche potenti tanto quanto l’Es (si pensi ai forti sensi di colpa di cui può soffrire un paziente). Al di là di queste caratterizzazioni, quello che Migone sottolinea è che la psiche per Freud era divisa, in conflitto, e che il compito della terapia poteva essere quello di dipanare questi conflitti, ad esempio chiarendoli meglio, facendoli venire alla luce, rendendo l’Io più padrone, più capace di gestirli, prendendo distanza ad esempio da sue motivazioni in conflitto o non integrate col resto della personalità. L’obiettivo della terapia voleva essere in sostanza quello di armonizzare le varie parti della psiche “unificandola”, eliminando cioè le “divisioni” interne, divisioni che possono paralizzare la persona impedendole di raggiungere i propri obiettivi di vita. Da questo punto di vista, potremmo dire, ad esempio, che quando la psiche funziona in modo ottimale e armonioso, vi è un “Io forte”, equilibrato, e così via, ma la cosa interessante è che alcuni autori – come ad esempio Heinz Kohut – in questo caso usano l’espressione “Sé coeso”. Va precisato però che Kohut – diversamente da Heinz Hartmann che nel 1950 definì il Sé come la rappresentazione della persona da parte dell’Io – usava il termine Sé per alludere alla totalità della persona, non necessariamente in conflitto con se stessa e dotata di un programma di sviluppo che porta all’autorealizzazione armoniosa di se stessa in presenza di un ambiente facilitante. Quindi siamo di fronte a un’altra posizione filosofica, a una differente concezione dell’uomo, e infatti questo Sé non ha conflitti innati e tende alla socializzazione con gli altri. Certo, potranno esservi dei conflitti, ma non tra strutture interne bensì tra il Sé e l’ambiente, tra il Soggetto e l’Oggetto, conflitti che poi possono anche venire internalizzati e quindi sembrare conflitti intrapsichici (diventano “l’ombra dell’oggetto”), ma possono virtualmente risolversi se vi è un ambiente ottimale perché la persona (il Sé) tende naturalmente ad andare d’accordo con se stessa e con gli altri. Molti degli approcci che usano il termine Sé, ad esempio, rifiutano le pulsioni freudiane (quindi l’idea di conflitto intrapsichico): Harry Stack Sullivan e la psicoanalisi interpersonale americana negli anni 1930-40 avevano abiurato alla teoria delle pulsioni (e per questo avvenne la rottura con la psicoanalisi di allora); Kohut non credeva nelle pulsioni, cioè non credeva che esistesse la struttura tripartita Es/Io/Super-Io ma, come si è detto, che esistesse solo il Sé, e che quando comparivano le pulsioni, o le strutture Es/Io/Super-Io, queste fossero solo un “prodotto di disintegrazione”, un by-product, di un fallimento empatico nella relazione (è per questo che diceva che il complesso di Edipo non era primario, ma secondario a un difetto nella relazione con la madre, la quale veniva erotizzata dal bambino nel tentativo estremo di avere un rapporto con lei, di raggiungerla); la teoria delle relazioni oggettuali e la psicoanalisi relazionale contemporanea sottolineano l’importanza della relazione interpersonale come principale causa della psicopatologia; e così via. Migone in questo seminario quindi discute alcuni aspetti del dibattito sul concetto di Sé, chiarendo anche la differenza tra il Sé e le strutture Es, Io e Super-Io, e fa alcune ipotesi sui motivi per cui nella psicoanalisi contemporanea viene sempre meno usato il termine Io e preferito il termine Sé. Per chi fosse interessato ad approfondire alcuni aspetti di questa problematica in rapporto alla “Psicologia del Sé” di Heinz Kohut, può consultare il capitolo 10 del libro di Paolo Migone Terapia psicoanalitica (FrancoAngeli, 1995, 2010).
Lectio di Paolo Migone
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Andrea Cortellessa Critico letterario e storico della letteratura italiana, professore associato all’Università degli Studi Roma Tre
Pino Donghi Direttore artistico, editor, conduttore, curatore di collane editoriali, saggista
Nicole Janigro Psicologa psicoterapeuta, giornalista e scrittrice
Romano Madera Filosofo e psicoanalista, ha fondato “Philo” (Scuola superiore di pratiche filosofiche) e SABOF (Società di analisi biografica a orientamento filosofico)
Giuseppe Previtali Assegnista di ricerca e Professore di Storia del cinema presso l’Università degli studi di Bergamo
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Alla guerra che non si ferma nel cuore dell’Europa, Synapsis dedica un intero ciclo di lezioni in collaborazione con la rivista “doppiozero” e i suoi intellettuali. Com’è nostra vocazione, spaziamo in diversi campi del sapere anche nell’affrontare il concetto di “guerra”, associandolo a diverse discipline che ne aiutino la comprensione, se non l’accettazione.
Ha una prospettiva filosofica la dissertazione del filosofo e psicoanalista Romano Madera, che nel chiedersi se la guerra sia inevitabile, la spiega attraverso la teoria della “pseudo-speciazione”, introdotta dallo psicologo e psicoanalista Erik Erikson, poco utilizzata nelle scienze umane, molto nella psicologia sociale e nell’etologia umana. Secondo la quale, a differenza del mondo animale, la specie umana non riconosce il nemico come tale, mettendo in atto dinamiche che, a partire dall’antichità, sacrificano vittime quali capri espiatori. Più strettamente allegata all’attualità del conflitto in Ucraina è la coda dell’intervento di Madera, che risale alle radici storiche e culturali, necessariamente da conoscere, di un evento annunciato.
Con taglio storico, documentato sulle fonti, la psicoterapeuta Nicole Janigro ricostruisce i legami con la Grande guerra di Sigmund Freud e dell’allievo Gustav Jung. Come rivelano scritti e lettere, il padre della psicoanalisi se ne trovò coinvolto inizialmente per la leva dei figli maschi, fino a che le nevrosi traumatiche arriveranno a influenzare il suo pensiero, formando nuovi materiali alla psicoanalisi. Mentre Jung, allo scoppio della guerra ufficiale medico ma da tempo perseguitato da incubi e visioni di morti e sangue un’Europa devastata, attribuì lo scoppio del conflitto allo sfogo della psiche collettiva, arrivando ad assegnare un carattere psichico, costituito da miti e archetipi, a popoli e nazioni.
È ancora Nicole Janigro, nella sua seconda lezione, ad argomentare attraverso il pensiero di filosofi, scienziati, letterati la tensione verso la pace non ancora soddisfatta. Dopo il Novecento secolo più ogni altro afflitto da guerre, la cultura della pace è un articolo (28) della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, nonché educazione in alcuni Stati. Se Eric Fromm da filosofo si interroga sulle ragioni del male chiamando in causa l’anatomia della distruttività umana, l’etologo Irënaus Eibl-Eibesfeldt afferma l’urgenza di sviluppare una nuova cultura della pace superando ogni pregiudizio antropocentrico, mentre René Girard pone la rinuncia alla violenza quale conditio sine qua non per la sopravvivenza dell’umanità.
Con visione poetica che si apre alle arti tutte, il critico letterario e storico della letteratura Andrea Cortellessa ripercorre gli scritti memorabili folgoranti di poeti e letterati italiani tra le due guerre. Da Federico De Roberto che nella novella La paura oppone una natura snaturata ai parafernalia bellici, a Eugenio Montale che alla guerra dedicò solo una poesia di Ossi di seppia, folgorante per il verso “le notti chiare erano tutte un’alba”. Dagli interventisti Gabriele D’Annunzio e Ardengo Soffici al disilluso Carlo Emilio Gadda e al dolente Giuseppe Ungaretti, dalla memorialistica riscoperta dei soldati illetterati, fino alla violenza espressionista, autocensurata di Clemente Rebora: il sommo poeta della grande guerra.
Strettamente legata alla guerra, la scienza è responsabile delle più micidiali invenzioni belliche, non di rado trasformate in risorse per l’umanità. Pino Donghi, comunicatore scientifico, ripercorre la storia del legame tra guerra e scienza, ponendo l’accento sugli episodi più sconosciuti e curiosi, in relazione alle arti, allo spettacolo, a cinema. Dalle due guerre mondiali segnate dall’uso dell’atomica, attraverso le guerre post-coloniali del secondo Novecento, fino ai conflitti attuali dove anche la chimica e la biologia entrano in gioco, l’excursus bellico coincide, sorprendentemente, con la storia della scienza e dei più grandi scienziati.
Il ciclo comprende un’incursione anche nel cinema e nei media audiovisivi che con la guerra hanno sempre avuto uno stretto legame. Come argomenta in una documentata e trasversale lezione Giuseppe Previtali, le invenzioni cinematografiche e belliche sono così legate da avere radici linguistiche comuni (si pensi al verbo inglese to shoot: sparare e fotografare). Dalla prima guerra mondiale le immagini prodotte hanno valenza politica, così che scegliere di diffonderle o censurarle è volontà dei governi: dal fungo atomico alle ombre di Hiroshima, dal “falling man” dell’11 settembre ai crudi rituali jihadisti. Con un punto di vista che è ormai quello della macchina e non più del combattente, le immagini dei conflitti attuali, compreso quello in Ucraina, hanno l’accurata confezione della propaganda.
Guerra una prospettiva filosofica
lectio di Romano Madera
Freud e Jung
lectio di Nicole Janigro
Fromm e l’etologia
lectio di Nicole Janigro
Guerra e poesia
lectio di Andrea Cortellessa
Guerra e scienza
lectio di Pino Donghi
Guerra e cinema
lectio di Giuseppe Previtali
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
È ormai da circa gli anni ‘60 che i sogni hanno perso quel posto centrale che avevano nella pratica clinica dello psicoanalista. Si è notato progressivamente uno spostamento di interesse dall’interpretazione dei sogni all’interpretazione del comportamento nella vita diurna, al materiale cioè più vicino all’Io e alla parte consapevole del paziente: sintomi, atti mancati, fantasie, modalità relazionali, etc.
Questo materiale infatti, grazie anche alla sempre maggiore esperienza e attenzione degli psicoanalisti, è di per sé già molto ricco e interessante per la comprensione del funzionamento conscio e inconscio del paziente, per niente inferiore al materiale rivelato da quella che Freud definì la “via regia” per conoscere l’inconscio, cioè i sogni.
Questo spostamento di enfasi ha cause complesse, che Paolo Migone discute in questo seminario. Quello che è interessante è che nei tempi recenti si è assistito a una rinascita dell’interesse verso i sogni, con produzione di articoli, libri, organizzazione di convegni e così via. Questa riscoperta del sogno da parte della psicoanalisi con tutta probabilità è dovuta da una parte alle nuove acquisizioni delle neuroscienze e dall’altra a un modo diverso di intendere la clinica psicoanalitica, che si discosta abbastanza da quella concepita dal fondatore della psicoanalisi e che a sua volta risente delle posizioni, sempre più diffuse, della Psicologia del Sé. Ad esempio Jim Fosshage, un analista che appartiene all’area della Psicologia del Sé (e conosciuto anche per alcuni libri scritti assieme a Lichtenberg e Lachmann), in vari lavori descrive in termini molto chiari un modo di comprendere i sogni e di usarli clinicamente che è sempre più prevalente nel movimento psicoanalitico ed è diverso da quello tradizionale.
Freud scrisse L’interpretazione dei sogni nel 1899 e uscì con la data del 1900, allo sbocciare del nuovo secolo. Egli aveva formulato l’ipotesi che, tranne alcune eccezioni, i sogni (così come altri comportamenti) fossero essenzialmente motivati dalla soddisfazione di un desiderio (e, per di più, di un desiderio sessuale o aggressivo) che veniva censurato dal “lavoro onirico” con la produzione di un contenuto “manifesto” che nascondeva un messaggio sottostante, parallelo, il contenuto appunto “latente”. Questa censura aveva uno scopo difensivo, per permettere la gratificazione di certi impulsi senza però disturbare il sognatore: infatti il sogno poteva essere considerato il “guardiano del sonno”. Oggi invece molti analisti rivalutano l’aspetto manifesto dei sogni come immagini che hanno una validità in se stessa, che va rispettata ed eventualmente capita in altro modo. Non si crede più tanto in quella che alcuni hanno chiamato teoria del “doppio binario”, cioè che vi siano due racconti paralleli: quello del sogno manifesto (mascherato, censurato, simbolizzato) e quello del sogno latente (il racconto “vero” che risulta dall’interpretazione o traduzione del primo). Le immagini manifeste del sogno possono invece non esprimere affatto qualcos’altro ma avere valore in se stesse e rappresentare semplicemente un modo di elaborare le informazioni attivo durante il sonno, e anche una specifica modalità di funzionamento cerebrale. Durante il sonno i contenuti mentali vengono continuamente rielaborati e questa è un’attività fisiologica che ha pari dignità, potremmo dire, di quella che avviene durante la veglia. Come hanno dimostrato vari ricercatori sia all’interno che all’esterno della psicoanalisi, non è vero che il “processo primario” (basato prevalentemente su immagini, caratterizzato da assenza del senso del tempo, condensazione, principio di piacere, etc.), di cui il sogno secondo Freud era la tipica espressione, rappresenta una modalità regressiva di funzionamento e che deve trasformarsi nel “processo secondario” (quello razionale, logico, verbale, basato sul principio di realtà, etc.). Il processo primario deve rimanere tale ed è importante per un ottimale equilibrio psicologico e anche per la sopravvivenza. Non solo, ma in determinati aspetti è ancora più importante di quello secondario, e deve funzionare in sinergia con esso. Assolve semplicemente a funzioni diverse. Sarebbe quindi sbagliato “tradurre” le immagini di un sogno in qualche significato latente dotato di un senso preciso: si rischia in questo modo di ridurne la complessità e sminuire le mille altre sue possibili funzioni. Qui sembra che vi sia anche una rivalutazione di idee che ebbe Jung, secondo il quale il sogno non andava “tradotto”, ma rappresentava semplicemente un’altra realtà.
Ma quali sono allora le funzioni del sogno, secondo questi psicoanalisti che oggi ne rilanciano l’interesse? Esse sono essenzialmente funzioni di crescita, problem-solving, mantenimento, regolazione, e, se necessario, riparazione (cioè guarigione) dei processi psichici allo scopo di favorire sempre un migliore adattamento e funzionamento mentale. Questa visione, come si può vedere, riprende la comprensione che vari autori cognitivisti hanno del sogno ed è anche coerente con la Psicologia del Sé secondo la quale il Sé ha un programma innato di sviluppo, volto alla crescita, all’adattamento e alla socializzazione, in armonia – in condizioni ottimali – con il mondo esterno. Diversa era invece la concezione freudiana, che prevedeva un conflitto innato, una sorta di ostilità con la realtà esterna, sulla quale l’Io aveva bisogno di scaricare determinate energie pulsionali.
In questo seminario quindi Paolo Migone accenna a varie problematiche legate all’attuale dibattito sulla concezione del sogno, mostrando la vicinanza di certe concezioni psicoanalitiche attuali alle concezioni cognitiviste e facendo anche alcuni interessanti esempi di sogni (ad esempio la descrizione di certi sogni che si possono definire paradossali, e i modelli teorici con cui possono essere spiegati).
Lectio di Paolo Migone
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
In questo seminario Paolo Migone spiega in dettaglio il concetto psicoanalitico di identificazione proiettiva sulla base della descrizione che ne fece Thomas H. Ogden in un articolo del 1979, poi inserito nel suo libro del 1982 Identificazione proiettiva e tecnica psicoterapeutica (Roma: Astrolabio, 1994).
La discussione di Ogden di questo concetto è una delle più chiare e permette facilmente di comprenderne tutti i risvolti teorici e clinici. Ogden, che risentiva dell’influenza kleiniana e soprattutto bioniana, divide il processo dell’identificazione proiettiva in tre fasi: proiezione, pressione interpersonale, e re-internalizzazione. Ogni fase viene descritta e spiegata facendo riferimento ad esempi clinici e vengono fatti anche collegamenti con termini e concezioni fuori dal campo psicoanalitico, appartenenti alla tradizione (quali il malocchio, la fattura, la possessione, etc.). Non solo: vengono fatte considerazioni anche su altri concetti collegati, peraltro oggi al centro del dibattito psicoanalitico: si accenna ad esempio ai temi del controtransfert, dell’empatia, del rispecchiamento e dell’intersoggettività.
Per quanto riguarda il controtransfert, ad esempio, Migone descrive la concezione “ristretta” di controtransfert che aveva Freud (che lo considerava un ostacolo al lavoro analitico) e quella “allargata” o “totalistica” inaugurata da Paula Heimann e Heinrich Racker dei primi anni ‘50 (che cominciarono a ritenerlo utile per conoscere l’inconscio del paziente), fino ad arrivare al dibattito contemporaneo che vede anche posizioni moderate, come quella di Morris Eagle, che sottolineano i rischi di allontanarsi troppo dalla posizione freudiana (Eagle ha esposto queste sue riflessioni in un importante articolo, dal titolo “Il controtransfert rivisitato“, uscito sul n. 4/2015 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane, di cui Migone è condirettore). È importante una discussione del controtransfert perché Migone mostra bene come l’identificazione proiettiva sia praticamente sovrapponibile al controtransfert inteso nella sua concezione allargata. Per quanto riguarda il concetto di empatia, studiato anche prima della psicoanalisi, fu utilizzato da Carl Rogers e poi all’interno della psicoanalisi da Heinz Kohut, con risvolti sia conoscitivi che terapeutici. Connessa all’empatia è la tematica del rispecchiamento, sottolineata, tra gli altri, da Donald Winnicott e nei tempi recenti da vari autori che fanno riferimento alla tematica della mentalizzazione e, all’interno delle neuroscienze, dei neuroni specchio. Infine, vari esponenti della psicoanalisi contemporanea (Bob Stolorow, Jessica Benjamin, Owen Renik e altri) propongono un paradigma “intersoggettivo” che si distanzia nettamente dalla “teoria del conflitto moderna” rappresentata dalla revisione teorica operata da autori “classici” quali Charles Brenner e Jack Arlow ma che, a ben vedere, ha anche importanti somiglianze spesso sottovalutate (queste considerazioni vengono fatte da Chris Christian in un interessante articolo pubblicato sul n. 2/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane). Un aspetto importante di questo seminario quindi consiste nel fatto che nella discussione dell’identificazione proiettiva vengono fatti riferimenti anche ad altri concetti psicoanalitici che sono collegati ad essa, chiarendone per quanto possibile le differenze e le somiglianze.
Per chi fosse interessato, una trattazione approfondita di questa tematica è nel capitolo 7 del libro di Paolo Migone Terapia psicoanalitica (FrancoAngeli, 1995, 2010).
Lectio di Paolo Migone
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Marco Belpoliti Saggista, scrittore, docente universitario, direttore della rivista e casa editrice www.doppiozero.com
Gabriella Caramore Saggista e conduttrice radiofonica, docente presso Associazione Nuova Accademia
Nicole Janigro Psicologa psicoterapeuta, giornalista e scrittrice
Gianfranco Marrone Professore Ordinario di Filosofia e teoria dei linguaggi presso l’ Università di Palermo; Direttore del Centro
internazionale di Scienze Semiotiche di Urbino
Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II
Anna Stefi Psicologa, docente di scuole superiori, vicedirettrice della rivista www.doppiozero.com e redattrice della collana Riga
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Il nuovo ciclo di webinar curato dalla rivista “doppiozero” ha per oggetto i modi del sentire: un mosaico di interpretazioni che a partire da analisi etimologiche e attraverso citazioni letterarie e teorie filosofiche cerca definizioni contemporanee per la gratitudine, l’ansia, la libertà, la noia, la pigrizia, l’ira. Moti dell’animo che accompagnano la condizione odierna. L’impostazione multidisciplinare dei sei interventi si apre su una doppia prospettiva: se è possibile rinvenire anticipazioni del pensiero psicologico in narrazioni e riflessioni non strettamente teoriche, d’altra parte è altrettanto possibile trovare tra le pagine di un romanzo o di un saggio l’impiego di teorie e concetti elaborati dalla psicologia e dalla psicoanalisi.
Anna Stefi riflette sul valore del dono nella sua analisi della gratitudine. Oltre la logica di scambio cui la contemporaneità mercantile ci ha assuefatto, che tende a privare di valore ciò che non chiede compenso, il donare basta a sé, non ha altra ragione che la propria. È un gesto originario a perdere, un’eccedenza che mette in moto un circolo del dono. Una logica della dissipazione nella quale entrambe le parti restano senza aspettativa da un lato né diffidenza dall’altro, un atto di generosità spontanea, che nobilita chi lo fa e chi lo riceve. Se già secondo Seneca il dono educava il mondo alla gratitudine mentre per la religione cristiana resta consustanziale, oggi la cultura dell’eccedenza può essere un’esperienza sacra da vivere da laici.
Per definire l’ansia, sensazione inafferrabile che tutti noi sperimentiamo, Nicole Janigro ne analizza le diverse carature. Certo è che dalla seconda guerra mondiale siamo diventati abitanti del mondo dell’ansia, paesaggio eletto della letteratura e dell’arte del Novecento. Una condizione non normale che tuttavia può servire a raggiungere obiettivi, come ormai si tende a teorizzare, considerata sempre meno patologia quanto piuttosto protagonista perenne della contemporaneità, che permette di affrontare la performance del vivere con le sue continue sollecitudini, fisiche e mentali. Benché dall’ansia quale sensazione di essere vitali sia breve il passaggio che conduce all’angoscia, alla fobia, al panico.
È drammaticamente calata nell’attualità così come nella condizione contemporanea dell’essere umano la dissertazione sulla libertà di Gabriella Caramore, che ne mette in luce il legame con la sfera delle emozioni. Un sentire che può essere collettivo quanto personale, crocevia tra la storia e l’individuo. Alla connotazione sociale dell’anelito alla libertà riconducono le immagini della vicina guerra in Ucraina così come di tutte le guerre in corso. La sfera personale della tensione alla libertà permette di riconoscere a un primo sguardo le persone coraggiose, anche nella quotidianità abitate da un sentimento forse innato. Quale ne sia l’espressione, la libertà è un gesto espansivo, relazionale e “politico”, capace di accendere fuochi e risvegliare coscienze.
È una cartografia del sentimento della noia quella che Marco Belpoliti traccia tra la letteratura e la filosofia del Novecento. Da Heidegger a Moravia, la strana indifferenza che accomuna tutti gli esseri e persino le cose, spesso descritta come una “nebbia” silenziosa che ottunde e in cui ci si smarrisce, ha una stretta relazione col tempo, quello della coscienza e quello della natura, fatalmente contrapposti in uno squilibrio inquietante. L’horror vacui dentro il tempo, sentito come un’eternità vuota, configura la noia quale “tonalità affettiva” in rapporto alla problematicità della nostra esistenza, di cui avvertiamo dolorosamente il nulla quando manca un orizzonte di senso.
Gianfranco Marrone ha voluto connotare il suo intervento sulla pigrizia con un titolo: “La fatica di essere pigri”. All’apparenza un paradosso, che tuttavia, oltre a all’aspetto psicologico, ne evidenzia le implicazioni sociali, soprattutto delle giovani generazioni. La condizione contemporanea, tanto più dopo l’evento pandemico che ha sconvolto la quotidianità dell’Occidente, riconfigura la pigrizia quale passione intersoggettiva: una reazione fino alla ribellione verso coloro che impongono la cultura dell’attivismo quale valore supremo. Ai quali il pigro risponde collettivamente, rifiutandosi di agire e resistendo, adoperandosi dunque tutt’altro che pigramente per attivare la sua inerzia simbolicamente efficace.
Ugo Morelli racconta l’ira quale esperienza tra le più impegnative e insieme consuete della nostra vita e delle relazioni con gli altri. Inscritta nella Bibbia tra i peccati capitali, si accredita ormai quale manifestazione comportamentale sostenuta dalle nostre emozioni di base, che in uno stato di particolare emotività esprime la nostra aggressività verso il mondo o contro gli altri. L’essere “fuori di sé” quale “tensione rinviante” è nostra caratteristica, che si trasforma in ira, fino all’aggressività, se non governata. Dacché per la combinazione di storia individuale e precedenti evolutivi, il libero arbitrio non sempre prevale, come già Freud teorizzò e gli studi neuroscientifici e psicologici dimostrano. Salvo valutare dell’ira anche l’accezione di risorsa.
Anna Stefi racconta la gratitudine – lezione
Nicole Janigro racconta l’ansia – lezione
Gabriella Caramore racconta la libertà – lezione
Marco Belpoliti racconta la noia – lezione
Gianfranco Marrone racconta la pigrizia – lezione
Ugo Morelli racconta l’ira – lezione
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Maria Silvana Patti, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del Servizio di Psicotraumatologia e del Master in Psicotraumatologia dell’ARP di Milano. Membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia, Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Completa la trilogia di Synapsis dedicata alla guerra un webinar che analizza negli aspetti pratici l’individuazione del trauma, gli esiti psicopatologici e l’intervento terapeutico cui sottoporre chi ne è vittima.
Tra i numerosissimi conflitti in corso, ad aver risvegliato le coscienze dell’Occidente è la vicina guerra in Ucraina, che affliggerà di effetti psicopatologici dovuti all’esposizione prolungata non solo le vittime dirette, ma tutti coloro che, a varia intensità, la subiscono: la popolazione civile, i soccorritori, gli operatori di ong, i cronisti, fino a noi tutti che nell’infodemia attuale siamo passibili di un trauma vicario.
A premessa storica Maria Silvana Patti ripercorre gli studi legati ai traumi di guerra, fatalmente condizionati dall’evolversi delle tecniche militari fino alla comparsa delle armi di distruzione di massa. Già Senofonte nell’Anabasi riferiva di comportamenti depressivi nelle truppe. Ma i primi studi scientifici sulle reazioni traumatiche dei combattenti datano fine Ottocento, con il concetto di “trauma psichico” formulato dal neuropatologo tedesco Hermann Oppenheim. Inascoltato fino alle prove di nevrosi traumatiche notate nella prima guerra mondiale, quando i sintomi dei soldati venivano piuttosto ricondotti all’isteria e visti con sospetto per il disvelarsi di fragilità personali inconcepibili nella retorica di guerra. Sono invece valide ancor oggi alcune linee di trattamento emerse dal secondo conflitto mondiale, che vide il coinvolgimento massiccio della popolazione con esiti devastanti sui civili. Fino alla guerra del Vietnam, crudamente coperta dai media oltre la censura imposta. Noto è il fenomeno dei reduci gravemente traumatizzati che si affidarono ad “autocure” con uso di sostanze o alcool, ma anche a gruppi di “autoaiuto” poi confluiti in reti terapeutiche organizzate. Finalmente nel 1980 il DSM III riconobbe come categoria diagnostica il “disturbo da stress post traumatico”.
Nella contingenza del conflitto in Ucraina la docente espone le fondamentali linee guida per interventi d’emergenza, analizzando sintomi ed esiti psicopatologici dei traumi di guerra. Con una particolare attenzione al trattamento dei bambini, considerando che i genitori stessi, pure vittime, ammettono difficoltà nell’assicurare sicurezza e protezione ai propri figli.
Un problema attuale e futuro, perché quale società potrebbe reggersi su individui incapaci di investire nel proprio progetto di vita e qualora la trasmissione del trauma diventasse transgenerazionale?
Lectio di Maria Silvana Patti
È possibile seguire la lezione senza il rilascio dei crediti ECM
Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
In questo seminario Paolo Migone ripercorre la storia il dibattito psicoanalitico sui fattori curativi e sull’importanza data alla relazione terapeutica, a partire da Freud e dal Congresso di Marienbad del 1936, passando attraverso la svolta del Congresso di Edimburgo del 1961, per arrivare al dibattito recente.
Freud concepiva due fattori curativi fondamentali: la comprensione e l’attaccamento (per la verità ve ne era un terzo, l’integrazione, che qui non viene preso in esame). Per “comprensione” Freud intendeva i fattori cognitivi, cioè l’interpretazione, la comprensione intellettuale, la spiegazione, l’istruzione, l’educazione, l’argomentazione logica, etc., mentre per “attaccamento” (da non intendersi come “teoria dell’attaccamento” di John Bowlby, a quei tempi non ancora formulata) intendeva gli aspetti emotivi, affettivi, relazionali, esperienziali, suggestivi, etc. Migone evidenzia come, contrariamente a quanto in genere si creda, Freud desse molta importanza al ruolo della relazione, da lui ritenuta un potente agente terapeutico, e non solo all’interpretazione, considerata da molti come l’intervento della psicoanalisi par excellence. Migone mostra la concezione che aveva Freud nei dettagli riportando anche sue citazioni, ed evidenzia come in realtà egli concepisse la psicoanalisi come una pratica terapeutica “a tutto campo”, con aspetti umani, educativi, identificatori, etc., all’interno dei quali l’interpretazione del materiale inconscio rappresenta solo una parte del trattamento, e spesso neppure la più importante. La terapia quindi, potremmo dire, è Bildung, cioè è anche la costruzione di un soggetto, che “impara” dal terapeuta, il quale trasmette anche valori e funge da modello per lui, come lo stesso Freud ha più volte osservato (volendo parafrasare Freud quando citava Leonardo da Vinci, la psicoanalisi quindi non funziona solo per via di levare, ma anche per via di porre).
L’autore cui Migone fa riferimento in questa ricostruzione storica del dibattito psicoanalitico sui fattori curativi è Larry Friedman, di New York, uno storico delle idee della psicoanalisi molto attento e colto, che è anche nella redazione della rivista Psicoterapia e Scienze Umane (di cui Migone è condirettore), il quale ha esposto queste sue riflessioni in un articolo del 1978 incluso poi come capitolo 4 del suo libro del 1988, tradotto anche in italiano, Anatomia della psicoterapia (Torino: Bollati Boringhieri, 1993). Secondo Friedman, negli anni 1950-60 avvenne una svolta, culminata nel dibattito sui fattori curativi avvenuto al congresso dell’International Psychoanalytic Association (IPA) di Edimburgo del 1961, che modificò la concezione della psicoanalisi che aveva Freud, e la rese una tecnica molto rigida, “classica”, in cui l’analista doveva restare il più possibile anonimo, parlare poco, stare dietro al lettino per non farsi vedere dal paziente, e intervenire soprattutto tramite le interpretazioni. Come espresso da Migone, questo atteggiamento analitico rappresenta una sorta di “personectomia” dell’analista, cioè, per così dire, un’asportazione chirurgica della persona dell’analista dalla relazione col paziente. Questa tecnica, che alcuni chiamano freudiana, per la verità non fu mai praticata da Freud, il quale quindi in questo senso non è mai stato un “freudiano”. Ma come mai si arrivò a questo irrigidimento, che come sappiamo ritroviamo un po’ ancora nello stereotipo dello psicoanalista rappresentato a volte nei giornali e in certi film? Il fatto è, argomenta Friedman, che nel 1961 il panorama dello sviluppo delle psicoterapie era ben diverso da quello di 20-30 anni prima: la psicoanalisi non dominava più incontrastata il mercato della psicoterapia e il suo monopolio era stato rotto dall’assedio di un vasto movimento di psicoterapie diverse, molte delle quali non solo efficaci, ma anche più economiche, più brevi, e quindi più appetibili. Probabilmente vari esponenti dell’istituzione psicoanalitica si sentivano minacciati e avevano bisogno di differenziare al massimo la specificità del metodo psicoanalitico, e naturalmente solo l’interpretazione si prestava a servire come “concetto forte” atto a questo scopo. Le componenti identificatorie e affettive, legate alla relazione col terapeuta, rischiavano di rientrare nei cosiddetti fattori “aspecifici” o “comuni” presenti in quasi tutte le psicoterapie, sminuendo l’originalità della psicoanalisi. In questo seminario Migone discute anche altri aspetti collegati a questo problema, come l’identità medica della psicoanalisi americana (è soprattutto negli Stati Uniti che sono avvenuti tali sviluppi), la traduzione delle opere di Freud in inglese di James Strachey che secondo alcuni avrebbe modificato certi significati che aveva voluto dare l’autore (secondo Bruno Bettelheim, ad esempio, la psicoanalisi nell’attraversare l’oceano avrebbe “perso l’anima” e acquisito maggiormente un’identità medica), e così via.
Per chi fosse interessato, una trattazione approfondita di questa tematica è nel capitolo 6 del libro di Paolo Migone Terapia psicoanalitica (FrancoAngeli, 1995, 2010).
Lectio di Paolo Migone