

Michael Garrett psichiatra, Clinical Professor of Psychiatry, Vice Chairman for Clinical Services, SUNYDownstate. Faculty, Psychoanalytic Institute at NYU Medical Center
Marco Solmi psichiatra, Professore Associato, Università di Ottawa, Canada
Tommaso Boldrini psicologo clinico e psicoterapeuta, ricercatore, Università di Padova
Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la schizofrenia è un disturbo mentale che produce elevati livelli di disabilità e che colpisce circa 21 milioni di persone a livello globale, di cui il 50% non riceve cure appropriate (OMS, 2017). Se fino a pochi decenni fa i disturbi psicotici venivano descritti come malattie cerebrali degenerative (ipotizzando l’esistenza di un unico processo biologico sottostante), oggi le evidenze scientifiche indicano sindromi dai confini più complessi e variegati, che è possibile prevenire e ripensare in termini di “recovery”. Questo seminario propone una rilettura clinico-scientifica degli interventi psicoterapeutici e biologici – e della loro efficacia – attualmente impiegati per il trattamento dei disturbi psicotici. Verrà anche proposta e una riflessione storico-culturale su come i diversi paradigmi si siano evoluti nel corso del tempo.
Verrà illustrato un modello integrato di psicoterapia (Garrett, 2021) che combina l’approccio cognitivo-comportamentale con quello psicodinamico in due fasi sequenziali: una fase iniziale in cui vengono principalmente utilizzate tecniche CBT per esaminare la falsità letterale delle idee deliranti e una seconda in cui si utilizza un approccio psicodinamico per esaminare la verità figurativa (il significato personale specifico) contenuta nei sintomi psicotici. Questo modello sembra presentare le potenzialità per superare sia i limiti del modello CBT-p, più focalizzato su specifici contenuti cognitivi che sugli aspetti fenomenologici nucleari dei disturbi psicotici, sia quelli del modello psicodinamico classico, che tende a porre un’attenzione eccessiva e precoce all’interpretazione dei significati inconsci dei sintomi a discapito dei meccanismi cognitivi del paziente e dell’esperienza cosciente dei suoi sintomi.
Saranno inoltre discussi i risultati più recenti degli studi di meta-analisi e di coorte sull’efficacia e la tollerabilità dei trattamenti biologici (farmacologi e non) nei bambini, negli adolescenti e negli adulti. A seguito della scoperta dei neurolettici – un fortunato caso di serendipità – la psicofarmacologia è oggi l’approccio dominante nel trattamento delle psicosi acute e svolge un ruolo significativo per molti pazienti nella prevenzione delle ricadute. Una riflessione sulle terapie biologiche più innovative e sicure, e su una corretta gestione dei farmaci, risulta fondamentale per gli operatori sanitari che, in prima linea, si trovano ad affrontare complessi processi di decision-making sui rischi e i benefici degli interventi pianificati.
Oltre alla necessità di promuovere interventi clinici (biologici e psicosociali) efficaci, le evidenze indicano che il timing di tali interventi risulta altrettanto fondamentale. Lo psichiatra e psicoanalista Harry Stuck Sullivan scriveva nel 1927: «Sono certo che molti casi incipienti [di schizofrenia] potrebbero essere trattati e risolti ben prima che il contatto con la realtà sia irrimediabile sospeso e una lunga permanenza nelle strutture istituzionali diventi necessaria». A distanza di quasi un secolo, di quali strumenti preventivi disponiamo per raggiungere tale obiettivo? Oggi abbiamo a disposizione strumenti per individuare adolescenti e giovani adulti che, pur non soddisfacendo i criteri diagnostici per una psicosi sindromica, vengono considerati ad alto rischio di sviluppare un disturbo psicotico in un periodo di tempo relativamente breve (il rischio stimato di sviluppare un disturbo psicotico è del 15-40% nei 12-36 mesi successivi alla valutazione diagnostica). Verranno presentati sia i principali strumenti diagnostici per individuare giovani a rischio di psicosi sia i protocolli di trattamento preventivi più utilizzati e potenzialmente più sicuri, accettabili ed efficaci di quelli offerti nelle fasi successive del decorso del disturbo.
Lectio di Michael Garrett
“Aspetti dinamici e cognitivi della psicoterapia delle psicosi”
Lectio di Tommaso Boldrini
“Stati mentali a rischio di psicosi: valutazione e intervento precoce”
Lectio di Marco Solmi
“I trattamenti biologici della schizofrenia nei bambini, negli adolescenti e negli adulti”

Marco Belpoliti Saggista, scrittore, docente universitario, direttore della rivista e casa editrice www.doppiozero.com
David Bidussa Storico sociale delle idee, consulente editoriale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, collaboratore de “Il domenicale – il Sole 24 ore”
Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II
Mario Porro Studioso di epistemologia francese, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Fermi” di Cantù
Anna Stefi Psicologa, docente di scuole superiori, vicedirettrice della rivista www.doppiozero.com e redattrice della collana Riga
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
In occasione della Giornata internazionale della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio,
Synapsis in collaborazione con la rivista culturale “doppiozero” pubblica la serie di webinar dal
titolo L’esperienza del dolore.
Cinque docenti, cinque interventi sull’“esperienza del dolore”: un’espressione del filosofo Salvatore
Natoli che stigmatizza le forme del patire fisiche e psicologiche. Ne è metafora il vulnus della
Shoah, che ha accomunato e persino creato legami tra letterati, intellettuali, personalità del
Novecento.
Le lezioni sono tenute da studiosi che si avvalgono di fonti letterarie, filosofiche, artistiche, per
suggerire, anche a chi è impegnato nelle professioni sanitarie, una riflessione di stampo umanistico
sul tema del dolore fisico e psicologico. Le testimonianze di deportati divenuti celebri, scomparsi o
sopravvissuti ai lager, si arricchiscono di una prospettiva inedita se analizzate in modo non
diagnostico, stimolando una comprensione antropologica e psicoanalitica.
Marco Belpoliti indaga la cognizione del dolore in Primo Levi (1919-1987) partendo dal suo libro
di esordio, Se questo è un uomo (1946 e 1958). Dove la parola “dolore” compare per la prima volta
nel racconto di quanto avviene nel campo di detenzione di Fossoli, quando una famiglia di Tripoli,
presaga del viaggio verso Auschwitz che attende i prigionieri, inscena un simbolico rito funebre. È
il dolore antico di un popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell’esodo ogni secolo
rinnovato, osservato con gli occhi dell’ebreo laico, dalla formazione cristiana. Nel corso dei suoi
anni da scrittore Levi elaborerà una propria “teoria del dolore”, legato a stati fisici e psicologici,
senza una distinzione netta tra le due condizioni, benché la seconda fosse per lui ben peggiore della
prima. La laurea in chimica dopo gli studi liceali umanistici gli lascerà un’attenzione spiccata per il
dato biologico, una visione da antropologo. Non scientifica, ma focalizzata sulla condizione umana,
racchiusa nel titolo del suo libro più noto.
Come racconta David Bidussa, è proprio Primo Levi a introdurre in Italia Jean Améry (1912-
1978), in un articolo del 1978 su “La Stampa”, due mesi prima del suicidio dello scrittore austriaco,
per poi dedicargli un capitolo (intitolato appunto “Risentimento”) nel suo libro I sommersi e i
salvati. Il tema è come rapportarsi all’esperienza traumatica che entrambi hanno vissuto nei campi
di sterminio. Améry da ebreo per parte di padre, non praticante, e da partigiano della Resistenza
belga, torturato dalle SS, da cui nascerà il libro Un intellettuale a Auschwitz. Per entrambi gli
scrittori la riflessione è sul dolore sfociato in risentimento e la domanda è come la memoria del
dolore e l’esperienza di ricordarlo ne sia condizionata. Una questione pubblica, affinché il
risentimento non sia causa di oblio della memoria. L’atto suicidario di Levi a una decina d’anni di
distanza da Améry sigla i loro destini e la memoria della comune esperienza, di dolore e
risentimento.
È Anna Stefi a tracciare un ritratto biografico e psicologico dell’ebrea olandese Etty Hillesum
(1914-1943), luminosa figura femminile che ha attraversato con grazia e umanità l’esperienza
dell’Olocausto. Breve e intensa la vita della giovane donna dagli ideali alti e dalla vocazione
radicale. «Vorrei essere il cuore pulsante di un intero campo di concentramento» dice di sé nei Diari
(11 quaderni di cui uno smarrito) e nelle lettere scritti ad Auschwitz, al quale non si sottrasse per la
volontà di condividere la sorte del suo popolo. Divulgati tardivamente, i suoi scritti restituiscono
un’immagine dell’autrice che a qualcuno è parsa “imperdonabile”, persino scandalosa per le sue
irricevibili parole d’amore, uscite dalla miseria e dal degrado del campo: «Pensavamo che mai più
avremmo potuto ridere ed essere lievi, ma se poi ci si reca tra la gente ci si rende conto che c’è vita e
che questa vita si ripresenta nelle sue mille sfumature».
Altra figura femminile tra le più rappresentative dell’esperienza della deportazione è Germaine
Tillion (1907-2008), la cui vicenda biografica e professionale è ripercorsa da Mario Porro.
Etnologa francese arrestata durante la Resistenza e internata a Ravensbrück, nei suoi scritti
clandestini porta lo sguardo e l’esperienza della scienziata, per la quale osservare e analizzare
rispondono alla volontà di capire l’incomprensibile. E se nulla è più spaventoso dell’assurdo,
comprendere è già una prima forma di resistenza morale, dacché la ragione è per la studiosa la forza
maggiore di cui l’umanità dispone. La sua testimonianza è raccolta nel volume Alla ricerca del vero
e del giusto, nella cui prefazione Cvetan Todorov accomuna l’autrice a Etty Hillesum. E proprio
come Primo Levi, nella sua vita lunga oltre cent’anni, Germaine Tillion non si sarebbe mai
spogliata di quell’habitus di scienziata che aveva portato anche nel campo.
Accomuna Bruno Bettelheim (1903-1990) ad altri protagonisti del corso la biografia di ebreo del
Novecento, l’esperienza del dolore nel lager nazista, così come la scelta suicidaria. Ugo Morelli ne
ripercorre la vicenda esistenziale e professionale, inestricabilmente connessa al dolore patito e alle
stigmate di sopravvissuto dell’Olocausto. Il trauma, inteso come componente distruttiva e
regressiva ma dalle prospettive ristrutturanti e persino creative, è assunto come riferimento. Nel
caso dell’austriaco Bettelheim, liberato dal campo di sterminio come raramente accadde ed
emigrato negli Stati Uniti, l’orizzonte fu una carriera dedicata ai traumi e alla psicologia dei disturbi
della crescita, anche dello spettro autistico, formulando una terapia infantile e adolescenziale che
potesse alleviarne le sofferenze, le fiabe quali rappresentazioni dei miti psicoanalitici. Riletto oggi
dal relatore alla luce delle recenti scoperte delle neuroscienze, il percorso di Bettelheim si apre a
nuove interpretazioni.

Tommaso Boldrini psicologo clinico e psicoterapeuta, ricercatore, Università di Padova
Michael D. Garrett psichiatra, Clinical Professor of Psychiatry, Vice Chairman for Clinical Services, SUNY Downstate. Faculty, Psychoanalytic Institute at NYU Medical Center
Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)
Antonio Maone psichiatra, Dirigente ASL Roma 1
Andrea Polari psichiatra, Clinical Associate Professor, Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne
Vincenzo Villari psichiatra e psicoterapeuta, Direttore, Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale e S.C. Psichiatria S.P.D.C. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)
Se fino a pochi decenni fa la schizofrenia veniva descritta come una malattia cerebrale degenerativa (ipotizzando l’esistenza di un unico processo biologico sottostante), le evidenze scientifiche attuali indicano una sindrome dai confini più complessi e variegati, che è possibile prevenire e ripensare in termini di “recovery”. Lo psichiatra e psicoanalista Harry Stuck Sullivan scriveva nel 1927: “Sono certo che molti casi incipienti [di schizofrenia] potrebbero essere trattati e risolti ben prima che il contatto con la realtà sia irrimediabile sospeso e una lunga permanenza nelle strutture istituzionali diventi necessaria”. A distanza di quasi un secolo, di quali strumenti disponiamo per raggiungere tale obiettivo?
A seguito della scoperta dei neurolettici (un fortunato caso di serendipità), la psicofarmacologia è oggi l’approccio dominante nel trattamento delle psicosi acute e svolge un ruolo significativo per molti pazienti nella prevenzione delle ricadute. Tuttavia diversi studi hanno dimostrato che i farmaci antipsicotici, se utilizzati come monoterapia a lungo termine, possono portare a una progressiva compromissione del funzionamento psicosociale dei pazienti, indipendentemente dalla stabilizzazione dei sintomi. Il movimento della recovery, un cambiamento di paradigma avvenuto a metà degli anni Settanta, ha indicato un obiettivo più ambizioso della semplice riduzione farmacologica dei sintomi delle psicosi croniche, ponendo i pazienti/utenti dei servizi di salute mentale al centro del loro percorso di cura con la legittima aspettativa di riacquistare capacità funzionali per il lavoro e le relazioni interpersonali.
Nonostante la psicoterapia delle psicosi, integrata con altri approcci al trattamento, possa candidarsi per affrontare questa aspettativa, un atteggiamento pessimistico ha sempre ostacolato il suo impiego nella pratica clinica. Freud non credeva che i pazienti psicotici potessero instaurare un transfert analizzabile e dunque non aveva fiducia nell’efficacia della psicoanalisi per il trattamento della psicosi. Con alcune eccezioni, la comunità psicoanalitica ha adottato l’atteggiamento di Freud e ha abbandonato la cura dei malati mentali gravi. Le scuole di specializzazione in psichiatria hanno seguito l’esempio, lasciando poco spazio all’insegnamento della psicoterapia nei programmi di formazione (Kimhy et al., 2013). Un’eccezione importante riguarda la psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT), anche se la maggior parte dei suoi sviluppi si sono concentrati sui disturbi d’ansia e depressivi – nonostante uno dei primi report CBT fosse proprio su un caso di psicosi (Beck, 1952). Attualmente un adattamento specifico dell’approccio CBT per i disturbi psicotici (CBT-P) viene raccomandato nelle linee guida internazionali, nonostante le evidenze meta-analitiche sulla sua efficacia siano controverse (Jones et al., 2018).
Questo seminario propone una rilettura clinica e scientifica degli interventi psicoterapeutici attualmente impiegati per il trattamento dei disturbi psicotici e della loro efficacia, anche attraverso una riflessione sulle radici storico-culturali del pregiudizio che li ha contraddistinti. Inoltre, verrà illustrato un modello integrato di psicoterapia (Garrett, 2021) che combina l’approccio cognitivo-comportamentale con la psicoterapia psicodinamica in due fasi sequenziali: una fase iniziale in cui vengono principalmente utilizzate tecniche CBT per esaminare la falsità letterale delle idee deliranti e una seconda in cui si utilizza un approccio psicodinamico per esaminare la verità figurativa (il significato personale specifico) contenuta nei sintomi psicotici. Questo modello sembra presentare le potenzialità per superare sia i limiti del modello CBT-P, eccessivamente focalizzato su specifici contenuti cognitivi piuttosto che sugli aspetti fenomenologici nucleari dei disturbi psicotici (anomalie dell’esperienza soggettiva, tra cui diminuito senso di presenza di un nucleo interiore, iper-riflessività e diminuito senso di ownership e agency dell’esperienza e dell’azione), sia quelli del modello psicodinamico classico, che tende a porre un’attenzione eccessiva e precoce all’interpretazione dei significati inconsci dei sintomi a discapito dei meccanismi cognitivi del paziente e dell’esperienza cosciente dei suoi sintomi.
Infine, verranno presentati alcuni paradigmi clinici – originariamente sviluppati in Australia e poi esportati nel resto del mondo – per la diagnosi e l’intervento precoce nei disturbi psicotici, con un’enfasi particolare sul clinical staging model, in cui la malattia psicotica viene considerata come un continuum stadiale, consentendo di guidare la logica e il timing degli interventi nella convinzione che i trattamenti offerti nelle fasi pre-morbose o prodromiche della malattia siano potenzialmente più sicuri, accettabili ed efficaci di quelli offerti nelle fasi successive del decorso del disturbo. Poiché questi paradigmi di intervento si rivolgono principalmente a giovani pazienti considerati a rischio di sviluppare un disturbo psicotico in un periodo di tempo relativamente breve (quindi potenzialmente in una fase prodromica del disturbo), il trattamento d’elezione è necessariamente psicosociale: la ricerca in questo ambito ha quindi portato a un rinnovato interesse per gli interventi psicoterapeutici non solo per trattare le psicosi, ma anche per prevenirne l’insorgenza negli individui che presentano manifestazioni cliniche attenuate o sottosoglia diagnostica.
ore 9:00 Introduzione di Vittorio Lingiardi e Vincenzo Villari
ore 9:45 Lectio Magistralis di Michael Garrett: “Aspetti dinamici e cognitivi della psicoterapia delle psicosi”
ore 10:30 Tommaso Boldrini: “Il trattamento delle psicosi in Italia. Evidenze sull’efficacia degli interventi e radici storico-culturali del nichilismo terapeutico”
ore 11:00 Antonio Maone: “Recovery clinica e recovery personale. Una nuova cornice concettuale per il trattamento dei disturbi mentali gravi”
ore 11:30 Andrea Polari: “Complessità dell’intervento precoce nelle psicosi: l’esperienza australiana”
ore 12:00 Discussione e domande dal pubblico – Chair Tommaso Boldrini

Mario Perini psichiatra, psicoanalista SPI, consulente d’organizzazione, socio fondatore e direttore scientifico Il Nodo Group
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Obiettivo formativo del corso è osservare le istituzioni, in particolare nelle loro parti “nascoste”: una metodologia essenziale per conoscerle, gestirle, cambiarle e per aiutarle a funzionare meglio e con meno costi umani. Tale metodologia viene descritta nei suoi aspetti teorici e applicativi.
Nelle organizzazioni lavorative gli obiettivi per i quali le persone operano sembrano chiari ed espliciti. Vi sono però altri bisogni, emozioni ed ansie di cui non c’è consapevolezza e che interferiscono, a volte pesantemente, con la “missione” dell’impresa o con i compiti istituzionali. Ci rendiamo conto di questo fatto quando scopriamo inaspettatamente in noi stessi o negli altri delle resistenze al cambiamento o quando ci rendiamo conto che i sistemi di regole che governano le organizzazioni vengono spesso utilizzati per mascherare rapporti di potere e di autorità che passano così completamente inosservati.
Come descritto nel volume di Mario Perini L’Organizzazione nascosta, è quindi particolarmente utile esplorare e comprendere più a fondo la dimensione emozionale celata nelle “zone d’ombra” dei processi istituzionali, delle relazioni di ruolo, dell’autorità, della leadership, dei meccanismi decisionali e gestionali che operano nei gruppi e nelle organizzazioni, con un’attenzione particolare alla loro capacità di promuovere o al contrario di ostacolare il compito istituzionale e le trasformazioni innovative.
L’osservazione istituzionale, nella sua forma partecipe e non-interferente, rappresenta un valido metodo di indagine, derivato dall’elaborazione di tecniche applicate con successo all’esplorazione delle relazioni terapeuta-paziente e madre-bambino oltre che del funzionamento dei piccoli gruppi.
Le sue radici teoriche si ritrovano essenzialmente in due filoni concettuali: quello dell’”osservazione partecipe” elaborato da Sullivan, fondatore dell’approccio interpersonale in psichiatria e in psicoanalisi, e quello dell’infant observation, introdotta da Esther Bick nel 1948 alla Tavistock Clinic.
Harry Stack Sullivan nel suo libro Il colloquio psichiatrico (1953) presenta il terapeuta come un “osservatore partecipe” impegnato in una situazione interattiva col paziente e sottolinea come il significato delle azioni umane non possa essere compreso solo attraverso operazioni intellettuali, ma soprattutto a partire dalle passate esperienze emozionali dell’osservatore. Per Sullivan il terapeuta contrae un coinvolgimento inevitabile in tutto quello che succede nel colloquio; e nella misura in cui non è consapevole o è ignaro della sua partecipazione, non si rende conto di cosa stia succedendo. In breve, egli sposta l’enfasi dall’osservazione del paziente basata sul transfert all’osservazione del paziente e dell’analista in interazione sulla base della matrice transfert-controtransfert.
Note sulla osservazione del lattante nell’addestramento psicoanalitico è il titolo del celebre saggio di Esther Bick del 1964, incluso come un capitolo del volume L’osservazione diretta del bambino, dove l’autrice descrive il metodo dell’Infant Observation come strumento di ricerca e di esplorazione della relazione tra la madre e il bambino, ma anche come metodo di training degli psicoterapeuti infantili e degli psicoanalisti. Bick sostiene che per la formazione alla psicoterapia dei bambini – ma anche degli adulti – ai terapeuti occorrono capacità e conoscenze specifiche che possono svilupparsi a partire dall’osservazione dei lattanti e dell’evoluzione della loro relazione con la madre (senza peraltro interferire con essa), in particolare la capacità di intuire i vissuti del loro paziente, di “percepire il neonato che era stato e che continuava a vivere in lui” e di comprenderne il comportamento non verbale. Come per Sullivan – e sotto l’influsso evidente dell’antropologo Bronislaw Malinowsky – anche secondo Bick l’osservatore deve essere “partecipe”, dunque non portatore di uno sguardo freddo, oggettivo e distaccato, ma in grado di provare un “impatto emotivo” da ciò che osserva.
Da queste precedenti ricerche muove l’approccio elaborato da Robert D. Hinshelwood e Wilhelm Skogstad nel loro libro Osservare le organizzazioni. Ansia, difesa e cultura nei servizi sanitari,
che descrive il metodo dell’osservazione istituzionale e le sue applicazioni. Questo metodo offre all’osservatore la possibilità di riconoscere le culture istituzionali inconsce e le forme in cui queste si manifestano nel comportamento dei singoli, dei gruppi e dell’organizzazione nel suo insieme. Ciò consente di studiare il funzionamento dei gruppi di lavoro e le risposte degli individui alle pressioni legate alla necessità di svolgere un compito o di affrontare un cambiamento, le ansie emergenti e le relative difese.
Il libro curato da Hinshelwood e Skogstad, presentando varie esperienze osservative svolte da diversi autori in alcune piccole unità operative all’interno di istituzioni più ampie appartenenti all’area dei servizi sanitari e sociali, mostra come le conoscenze ottenute con questo strumento possano contribuire a superare certe criticità organizzative.
Obiettivo dell’osservazione è dunque il riconoscimento e la comprensione dei processi latenti, inconsci e non-razionali che influenzano le relazioni interpersonali, intergruppali e intersistemiche all’interno di un’organizzazione, provocando disagio, perdita di efficienza e di creatività, resistenza al cambiamento e talvolta il fallimento nel perseguire gli scopi desiderati. Questa comprensione è essenziale per chiunque operi in un’organizzazione e intenda svolgere il proprio ruolo in modo efficiente ed efficace e con la dovuta attenzione per il “fattore umano”. L’osservazione istituzionale è inoltre un importante strumento per chi voglia operarvi come consulente, poiché permette di conoscere l’istituzione più “dall’interno”, di apprendere non solo teoricamente ma attraverso un’esperienza emozionale diretta, al fine di formulare ipotesi di lavoro sulla natura dei problemi individuati e di contribuire ad elaborare proposte di soluzione.
Studio dei testi:
Robert D. Hinshelwood, Wilhelm Skogstad (a cura di), Osservare le organizzazioni. Ansia, difesa e cultura nei servizi sanitari, Ananke, 2005
Mario Perini, L’organizzazione nascosta. Dinamiche inconsce e zone d’ombra nelle moderne organizzazioni, Franco Angeli, 2015
Esther Bick, Note sull’osservazione del lattante nell’addestramento psicoanalitico, in Susan
Isaacs et al., L’osservazione diretta del bambino, a cura di Vincenzo Bonaminio e Bianca Iaccarino, Bollati Boringhieri, 1984, pp. 70-89
Lettura consigliata:
Harry Stack Sullivan, Il colloquio psichiatrico, Fioriti, 2017, cap. 1, pp. 1-18

Mario Perini psichiatra, psicoanalista SPI, consulente d’organizzazione, socio fondatore e direttore scientifico Il Nodo Group
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Approfondire il ruolo, le forme, le dinamiche e le conseguenze dell’invidia nella vita organizzativa per imparare a riconoscerla, aumentare la consapevolezza della sua distruttività e sviluppare strategie e comportamenti che mirino ad arginarla e a ridurne gli effetti nocivi per le persone e per l’organizzazione.
Dell’invidia sono state date numerose definizioni, che condividono tra loro molti aspetti mentre si differenziano per il fatto di privilegiarne alcuni. Tra gli aspetti condivisi possiamo ritrovare la tendenza a caratterizzarla come un’emozione di insoddisfazione e di risentimento generata dal desiderio per le proprietà, le qualità o i successi di un’alta persona e della percezione dolorosa di inferiorità che scaturisce dal confronto con quella persona. Un aspetto rilevante dell’invidia riguarda i comportamenti che è in grado di mobilitare a livello individuale, gruppale e organizzativo, e gli effetti che ne derivano, talvolta costruttivi ma molto più frequentemente distruttivi; secondo molti studiosi di psicologia dell’organizzazione risulta chiaro come l’invidia nei luoghi di lavoro sia uno dei fenomeni distruttivi chiave, specialmente per la capacità di minare le figure di autorità e di compromettere il clima organizzativo, le relazioni di lavoro e i processi produttivi.
Le dinamiche distruttive dell’invidia sono state descritte in profondità da Melanie Klein nel suo saggio Invidia e gratitudine, dove questa emozione è considerata espressione primitiva dell’istinto di morte e viene descritta come un sentimento di rabbia che il bambino proverebbe verso il seno materno non solo quando questo è “cattivo” e frustrante, ma anche e soprattutto quando si presenta come “buono” e gratificante perché contiene qualcosa di prezioso che il bambino desidera ma che non possiede. L’invidia così porterebbe il bambino ad attaccare il seno proiettandovi le sue parti “cattive” per danneggiarlo e distruggerlo o depredarlo.
Riprendendo e tuttavia oltrepassando le ipotesi kleiniane, Wilfred Bion nel suo saggio Attenzione e interpretazione associa all’invidia la distruzione della “funzione alfa”, di quella funzione mentale che per mezzo dei suoi fattori trasforma le sensazioni grezze nei pensieri del sogno e della veglia, e l’attacco agli oggetti che stimolano la crescita e gli aspetti più evoluti della personalità. Per Bion l’invidia può determinare anche certe dinamiche di gruppo, come quando il gruppo cerca di distruggere il “mistico”, colui che al proprio interno si fa portatore della creatività e di idee nuove.
Nei luoghi di lavoro circolano molte emozioni, sulle quali però di solito non ci si sofferma più di tanto, soprattutto perché le culture aziendali le conoscono poco, non sanno come spiegarle e soprattutto come governarle. Tra queste emozioni la più negletta è certamente l’invidia. Ciò dipende
in larga misura del fatto che le persone tendono universalmente a negare di provarla, perché si tratta di un sentimento socialmente condannato e perché riconoscerla implica un’ammissione di inferiorità. Ma un contributo alla sua sottovalutazione deriva anche dalla tendenza del mondo aziendale a confonderla con l’emulazione, un atteggiamento certamente apparentato all’invidia ma capace di mobilizzare nelle persone una spinta a migliorarsi e a cercare di raggiungere i livelli dei top-performers.
Nel suo libro L’invidia al lavoro pubblicato nel 2007, Bénedicte Vidaillet osserva come questa emozione negata o misconosciuta sia «lì, in agguato nei team di lavoro, nascosta dietro l’ambivalenza che proviamo per un collega con cui lavoriamo fianco a fianco da anni, mascherata dalle reazioni dei dipendenti che gridano all’ingiustizia per non aver ricevuto una gratifica elevata come quella che è stata data ad altri». Nel considerarla all’origine di molte disfunzioni e di comportamenti aggressivi e distruttivi all’interno dell’organizzazione, Vidaillet mostra attraverso varie esemplificazioni come identificarne i sintomi nei gruppi di lavoro, come comprendere i meccanismi istituzionali che la generano e come mettere in atto delle strategie per contenerla e per evitare conseguenze devastanti.
Anche Manfred Kets de Vries nel capitolo 5 del suo saggio L’organizzazione irrazionale (2001) esplora le ricadute dei meccanismi invidiosi sulla vita organizzativa, e in particolare descrive le fonti istituzionali dell’invidia, i meccanismi di difesa e le modalità per gestirla, quelle distruttive (ad es. l’idealizzazione, il ritiro, la svalutazione, la vendetta, l’ostilità generazionale ecc.) così come quelle costruttive, la ricerca dell’eccellenza, la riparazione e la cooperazione di gruppo.
Studio dei testi:
Wilfred Bion, Attenzione e interpretazione, Armando, 1973
Melanie Klein, Invidia e gratitudine, Giunti, Milano 2012
Bénedicte Vidaillet, L’invidia al lavoro, Ananke, 2011
Manfred Kets de Vries, L’invidia e le sue vicissitudini in “L’Organizzazione irrazionale”, cap. 5, Raffaello Cortina, 2001
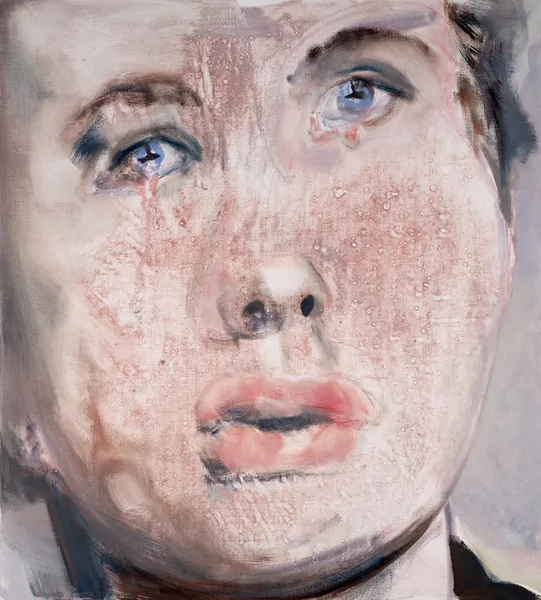
Marco Belpoliti Saggista, scrittore, docente universitario, direttore della rivista e casa editrice www.doppiozero.com
Nicole Janigro Psicologa psicoterapeuta, giornalista e scrittrice
Maddalena Mazzocut-Mis Professore ordinario di “Estetica” ed “Estetica della Musica e dello Spettacolo” presso l’Università degli Studi di Milano
Antonio Prete Critico letterario, poeta, scrittore, traduttore e accademico
Mauro Portello Docente di scuole superiori e collaboratore della rivista www.doppiozero.com
Anna Stefi Psicologa, docente di scuole superiori, vicedirettrice della rivista www.doppiozero.com e redattrice della collana Riga
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Il corso “Emozioni e sentimenti” è costituito da sei videolezioni, ciascuna delle quali è dedicata a un’emozione o sentimento: nostalgia, invidia, compassione, disgusto, felicità e resilienza.
Il corso ripercorre la genesi etimologica dei vocaboli associati alla sfera del sentire per indagare le radici profonde della loro origine semantica, seguendone l’evoluzione nel tempo e contestualizzando i fattori che hanno contribuito a risemantizzare quel termine e a importarlo all’interno di lessici specifici.
Tale percorso serve a spogliare le singole parole della veste generalista legata al linguaggio comune per restituirle al discente contestualizzate, problematizzate e arricchite di nuove possibilità: la storia del linguaggio è anche storia di concetti, che permette di esplorare nuove possibilità anche per le discipline scientifiche.
Tenute da studiosi dell’area umanistica, le lezioni si avvalgono di fonti letterarie, filosofiche e artistiche per esplorare le possibilità dell’immaginazione come strumento capace di scardinare la semplificazione e, talvolta, la banalizzazione che questi termini hanno subito.
L’obiettivo del corso è discoprire la portata semantica e storica delle parole associate ai sentimenti: il nodo chiave è il tema del sentire e, per questo motivo, l’innesto delle discipline umanistiche rappresenta sia un aggancio alla contemporaneità sia la ricerca di nuovi possibili strumenti di analisi.
Nelle parole di Marco Belpoliti: “Si diffonde in psicologia e psichiatria l’uso del testo letterario perché all’interno di esso, in modo spesso inconsapevole, sono presenti figure o atteggiamenti psicologici molto molto utili per la stessa psichiatria e psicologia”.

Mario Mattioda Consulente psicodinamico e operatore psicosociale. Collabora con diverse riviste tra cui “Psicoterapia e scienze umane”
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Innumerevoli i testi di psicologia, i romanzi, i film centrati sulla figura della madre, mutata nel suo ruolo nel corso del Novecento, con un’accelerazione decisiva negli ultimi anni. È proprio sul protagonismo della madre, ancor prima del suo rapporto con il figlio, che intende focalizzarsi questo percorso.
Partiamo dal saggio di Massimo Recalcati Le mani della madre, in cui l’autore affronta il tema della Madre, domandandosi cosa ne resti di lei al tempo della sparizione della sua rappresentazione patriarcale. Rigettando ogni nostalgia nei confronti dell’immagine “della madre del sacrificio e dell’abnegazione” imposta dalle leggi del padre-padrone, Recalcati concentra la sua analisi sull’attuale condizione femminile, non più appiattita sulla maternità, ma esposta a una tormentata integrazione tra l’essere donna e il ruolo di madre. Oggi infatti le donne lavorano, hanno raggiunto la libertà sessuale, non si propongono più quali “madri-coccodrillo” che divorano il loro frutto, ma “quali madri-narcise” che spesso vivono i figli come un ostacolo alla propria realizzazione sociale. Inoltre, in un’ipermodernità in cui il coito non è più necessario alla fecondazione, il sesso si allontana dalla natura per consegnarsi alla scienza: e la maternità da destino si trasforma in progetto, producendo una filiazione emancipata dalla dimensione naturalistica della famiglia. Una metamorfosi che impone una correzione di quelle letture preconcette della funzione materna che assegnavano alla madre il compito necessario ed esclusivo della cura del figlio o, all’opposto, uno spazio caotico e prelinguistico che soltanto l’intervento paterno poteva regolare.
Prestandosi il soggetto al cinema, proponiamo tre film disponibili sulla piattaforma Netflix, che spaziano tra Paesi e culture, tra epoche ed estetiche, documentando le variazioni di un istinto alla maternità messo in crisi dalla società occidentale emancipata. Con la cautela che un tabù impone.
Mother, film giapponese del 2020 di Tatsushi Omori, regista della nuova vague nipponica, presenta una madre che ha abdicato al proprio ruolo educativo, o meglio, non lo considera necessario per i suoi figli né per se stessa. La donna, cresciuta in una tradizionale famiglia piccolo-borghese, viene mostrata con crudezza nelle fasi sempre più estreme del rifiuto del suo ambiente, al quale preferisce il degrado di una vita da sbandata, vittima di alcool, delinquenza, profittatori. Un figlio primogenito e poi una bambina, entrambi senza padri, la seguono silenziosi e attoniti nella sua esistenza raminga, più come compagni di disavventure che come figli, privati di qualsiasi forma di educazione, genitoriale e scolastica. Mai, neppure al compimento dell’atto più estremo, la madre si pone dubbi sul proprio sciagurato comportamento, mai, nemmeno quando le conseguenze rovinano la vita del figlio e risparmiano la sua, si pente della propria nefasta influenza. Immagineremmo da parte dei figli ribellione e odio, invece no: obbedienza e amore, incondizionati a dispetto di tutto. Forse perché mai questa madre, protagonista ed egoista, sceglie di non far nascere o di abbandonare i suoi figli, nonostante le pressioni e le lusinghe della famiglia e della società.
Invisible, pellicola argentina datata 2017 del regista emergente Paolo Georgelli, già in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, propone un tema di attualità, avendo il paese sudamericano approvato di recente la legge sull’aborto. Nel film invece la vicenda è condizionata dal divieto ancora vigente all’interruzione di gravidanza, con cui si scontra la giovane protagonista quando scopre di essere incinta. Una ragazza di diciassette anni, come il titolo suggerisce “invisibile” agli occhi degli altri, siano la madre, l’amante, i compagni di scuola, i partner occasionali. Non bella, volutamente scialba, all’apparenza emotivamente indifferente ad ogni persona accanto a lei e ad ogni avvenimento le capiti, si direbbe condannata a una vita grigia e solitaria. Salvo la svolta, proprio nel finale, quando la decisione di non rinunciare alla maternità appare come il modo di manifestare la sua presenza al mondo, gradita o sgradita che sia. E di sentire finalmente su di sé lo sguardo di una creatura: la sua.
Si torna a una concezione tradizionale della figura materna nel film georgiano del 2017 My Happy Family, firmato dalla giovane coppia di registi Nana Ekvtimishvili e Simon Gross. In una società ancora fortemente patriarcale (che in realtà sono le donne a governare) Manana è una donna di mezza età che ha compiuto il suo ciclo biologico di figlia, moglie, madre e si appresta ad entrare nel ruolo di nonna. Agli anni che la attendono, scontato perno di una famiglia numerosa e problematica, la protagonista sceglie di sottrarsi per andare a vivere da sola, in un appartamento in affitto che il suo lavoro di insegnante le consente. Nella scarna semplicità della nuova casa, solo all’apparenza squallida, finalmente silenziosa quando non abitata dalla musica di Mozart, arredata appena da libri e fiori, la sua femminilità spenta rifiorisce, per bastare soltanto a se stessa. Inutile spiegare alla famiglia, preoccupata dal disonore sociale più che affranta dall’assenza di Manana, i motivi di una scelta che poche donne a quell’età e in quel contesto avrebbero il coraggio di compiere. Mentre allo spettatore appare chiaro come la ritrovata individualità della protagonista non significhi affatto abdicare al proprio ruolo di madre, al contrario governarlo senza esserne sopraffatta.

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Un libro di un noto psichiatra e un teen drama di successo aiutano a comprendere psicologia e comportamenti della “generazione Z”, mossa da un insostenibile bisogno di ammirazione cui fa da contraltare un’intollerabile vergogna.
Da sempre impegnato nell’assistenza psicologica ai ragazzi difficili, lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet ha nel suo Istituto “Il Minotauro” un osservatorio speciale sulle giovani generazioni.
Comportamenti e psicologia degli adolescenti della “generazione Z” (e degli adulti che ne condividono spazi e abitudini) sono oggetto di un’analisi lucida, a tratti feroce, esposta nel suo recente libro, L’insostenibile bisogno di ammirazione.
La riflessione psicoanalitica del clinico origina dalla constatazione che tanti di noi, adulti e ancor più adolescenti, siano ormai narcisi eccitati da un solo desiderio: essere ammirati. Non è più il senso di colpa, fondato sul conflitto, a influenzare i nostri comportamenti; a guidarci oggi è il nostro bisogno di riconoscimento sociale, di visibilità continua, di facile notorietà. Né importa affermarsi attraverso le proprie doti e competenze, e neppure ormai esibirne di inesistenti. La paura peggiore, piuttosto, sarebbe di finire in un cono d’ombra sociale.
L’accelerazione imprevedibile dell’attuale dinamica ha una causa secondo Pietropolli Charmet: la morte del patriarcato, con il suo rappresentante più noto, il Padre. Il vecchio modello educativo, durato sino agli anni Cinquanta, era improntato alla severità: la convinzione era che il bambino, dominato dalla sua natura pulsionale, avrebbe inevitabilmente commesso trasgressioni, sia di natura sessuale che aggressiva. Liquidato quel modello è apparso il bambino naturalmente buono, che i genitori hanno cercato di accudire e incentivare in ogni modo. Ed ecco la comparsa di tanti narcisisti.
L’egemonia della cultura etica, pregna – è vero – di esasperato moralismo, ha lasciato il posto a un individuo divenuto insensibile al patrimonio normativo condiviso, che pretende invece di realizzarsi con facilità e rapidamente. Oggi l’inconscio e disperato desiderio dei giovani – e sempre di più degli adulti – è, appunto, suscitare ammirazione. Sarebbe un sentimento del tutto naturale, senza nulla di patologico, se non nell’incontro con la frustrazione dell’indifferenza, con la mortificazione narcisistica. Se l’ammirazione cercata nello sguardo altrui, personale e sociale, non si manifesta, subentra la vergogna: risulta intollerabile essere considerati insignificanti, brutti, indesiderabili. Alla caduta dell’etica condivisa ha corrisposto l’ossessione dell’estetica perfetta, la protervia del potere seduttivo, la sfrontatezza dell’esibizione spudorata.
È una delle conseguenze dell’individualismo, dell’enfasi sul Sé: ma si tratta di un Sé fragile, terrorizzato di non essere all’altezza delle aspettative, che sprofonda facilmente in quella paura della vergogna ormai causa più diffusa del disagio psicologico.
«Finita l’epoca della colpa è cominciata quella della vergogna» afferma Gustavo Pietropolli Charmet. Non sarà un caso che la serie di Netflix Skam, creata in Norvegia, in norvegese significhi proprio “vergogna”. Il desiderio di accettazione, a tutti i costi, da parte dei coetanei, ovvero l’unico orizzonte che conta, muove i comportamenti degli adolescenti protagonisti della versione nazionale, Skam Italia, un successo annunciato dopo l’exploit del format in tutt’Europa.
Pensato come prodotto di entertainment per teen-agers, Skam dovrebbe essere visto anche da genitori e operatori sociali, perché offre uno sguardo realistico fino alla crudezza sull’adolescenza, senza concessioni al sentimentalismo o all’assoluzione. Tutto quanto non sappiamo o forse non vogliamo sapere della vita quotidiana dei nostri ragazzi è fissato nelle prime quattro stagioni della serie, ognuna dedicata a un protagonista e a un tema della crescita: la scoperta del sesso, l’orientamento sessuale, la relazione sentimentale, il divieto e la trasgressione. Tappe di formazione vissute freneticamente, senza alcuna riflessione né preparazione, condizionati dai nuovi modelli imposti dal web ancor più che dal consiglio o dallo sprone dei coetanei. Il rispetto per il proprio corpo e per l’integrità fisica, così come per l’equilibrio psicologico, è ormai dimenticato, vinto dalla baldanza di sfidarne la resistenza con la sfrenatezza di sesso, alcool, droghe, pratiche attualmente comuni alla maggioranza degli adolescenti, siano maschi o femmine. Dominano, per tutti, modelli di bellezza artificiale, disinvoltura sessuale, sballo orgoglioso, ricchezza arrogante.
La frenesia di vivere passioni malate non trova alcun argine nelle figure degli adulti, siano genitori, insegnanti, educatori, dei quali non c’è traccia nella quotidianità di questi adolescenti, nella serie come nella realtà. Una deriva educativa della società occidentale: non a caso nella serie i genitori sono presenti, con l’imposizione di divieti ancestrali all’opposto invalidanti, soltanto nella vita di una giovane protagonista di origine araba e religione islamica.
Lo studio, la formazione personale, appaiono solo come un sottofondo fastidioso e d’intralcio alla soddisfazione di sé, ben oltre la goliarda, nella logica di un vivere di espedienti e mediocrità. Resiste soltanto, ma chissà ancora per quanto, l’istituto della scolarizzazione. Totalmente assenti predisposizioni e passioni individuali, progetti e sguardi sul domani.
Un quadro sconfortante, considerando che gli adolescenti ritratti nella serie hanno la fortuna di appartenere a un’élite, che consente loro di frequentare un liceo, di vivere agiatamente, di non avere altra preoccupazione all’infuori dell’estemporanea soddisfazione di sé.
Unica sicurezza, destabilizzante se assente, è l’essere costantemente connessi al loro mondo tramite i social networks, nella falsa illusione di essere protagonisti perfetti di un mondo ideale, in verità figuranti teleguidati di una dimensione virtuale. Ancor più delle sostanze, forse è questa la più triste delle dipendenze.
La speranza di un senso perduto potrebbe nascondersi nella forza del gruppo, che se in qualche caso innesca derive di “branco”, riesce ancora ad offrire amicizia, sostegno, sentimenti autentici. Che siano da cercare in tale dimensione i fondamenti per una nuova educazione della generazione “Z”?

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Quando si parla di inconscio psicoanalitico e di inconscio cognitivo occorre precisare che non si tratta di due “fedi” in contrasto tra loro, ma di due tipi di processi inconsci studiati maggiormente da autori della tradizione psicoanalitica il primo e da autori di quella cognitiva il secondo. Ormai non vi sono più sostanziali differenze di opinioni sulla natura dell’inconscio, e questo è stato possibile anche grazie ai progressi delle neuroscienze. Si è capito per esempio che non esiste “un inconscio”, ma “molti inconsci”, e sia gli psicoanalisti che i cognitivisti sono ben consapevoli dell’esistenza di questi diversi tipi di inconscio.
La caratteristica principale dell’inconscio psicoanalitico è quella di essere “dinamico”. Questo significa che certi contenuti mentali possono passare dallo stato conscio a quello inconscio e viceversa. Un esempio tipico è quello di un trauma che può essere dimenticato perché troppo doloroso, ma che in certe condizioni favorevoli può tornare alla memoria. La psicoanalisi postula che il prezzo pagato per questa rimozione può essere un sintomo (una inibizione, una depressione, etc., o un sintomo isterico come nelle pazienti di Freud), che può improvvisamente scomparire se si riesce a ricordare quel trauma che era stato rimosso.
Secondo una certa concezione superata e ingenua dell’inconscio psicoanalitico, i ricordi rimossi vengono depositati nell’inconscio come se fosse un serbatoio, un magazzino, da cui poi possono essere recuperati tali e quali. Ma è stato dimostrato che la memoria rielabora continuamente i ricordi e li trasforma alla luce dei desideri e delle esperienze successive. Infatti così come, secondo il concetto di transfert, noi interpretiamo le esperienze presenti alla luce del passato, ugualmente, con un meccanismo uguale e contrario, possiamo distorcere i ricordi delle esperienze passate alla luce di quelle successive: questa sorta di “transfert inverso” fu chiamato da Freud Nachträglichkeit (tradotto bene dai francesi con après-coup), che significa appunto una attribuzione retrospettiva di significato.
Un’altra caratteristica dell’inconscio psicoanalitico è quella di essere, come una volta lo definì Freud, un “calderone ribollente” di impulsi e desideri. Questo aspetto lo rende molto diverso dall’inconscio cognitivo, dove non si parla di desideri che premono per essere gratificati ma si parla, più che di emozioni, di “cognizioni”, di pensieri, di problem solving, e di “processi” più che di “contenuti”.
Va precisato però che negli anni 1930 Heinz Hartmann, fondando la “Psicologia dell’Io”, fece la prima grande correzione nella storia della teoria psicoanalitica: teorizzò che non tutto l’apparato cognitivo origina dal conflitto con quel “calderone ribollente” dell’inconscio come riteneva Freud, ma una sua parte, che lui definì “area autonoma dell’Io libera da conflitti”, è innata. Quindi per certi versi si può dire che la concezione dell’apparato cognitivo secondo Hartmann, che poi è diventata la concezione psicoanalitica classica, si avvicini molto a quella cognitiva.
In che modo il terapeuta cognitivo utilizza l’inconscio a livello clinico? Per il cognitivista l’inconscio è concepito come una serie di rappresentazioni mentali implicite o tacite, cioè non consapevoli, le quali, se disfunzionali, vanno modificate in psicoterapia, cercando di renderle consapevoli perché possono motivare il cambiamento (la terapia cognitiva standard assume, in un modo che potremmo definire coraggioso, che non sono le emozioni a trascinare le cognizioni, che sono le cognizioni a trascinare le emozioni). Il terapeuta cognitivo cerca di far ragionare il paziente mostrandogli quanto le sue credenze possano essere disfunzionali o irrazionali, cioè lo rende consapevole dei suoi “pensieri automatici”.
Per “inconscio cognitivo” però non si intende esattamente questo, perché è simile a quello che in psicoanalisi viene definito “preconscio”: anche lo psicoanalista fa riflettere il paziente sulle sue motivazioni non del tutto consce, e in questo senso si può dire che la psicoanalisi sia “cognitiva” (si pensi anche alla interpretazione, intervento per eccellenza della psicoanalisi: essa è un intervento cognitivo, si trasmette al paziente una informazione).
Si suol dire che il cognitivismo è l’erede del comportamentismo, nel senso che si è passati dal semplice modello stimolo-risposta (S-R) alla concezione di una “mediazione cognitiva” che si infrappone tra S e R, cioè da una concezione meramente “ambientalistica” a un modello più complesso (tra l’altro, questo passaggio ricorda quello che aveva fatto Freud con l’abbandono della teoria del trauma per fondare la psicoanalisi vera e propria). Secondo questo luogo comune, dunque, il cognitivismo sarebbe nato dal comportamentismo per poi arrivare alla terapia cognitiva. In realtà i due padri storici della terapia cognitiva, Aaron Beck e Albert Ellis, provenivano dalla psicoanalisi, e volevano proporre un trattamento più semplice e più breve di quello psicoanalitico. Si potrebbe dire quindi che Beck ed Ellis erano due “psicoanalisti moderni” nel senso che miravano a rendere cosciente il paziente dei pensieri preconsci, originati da esperienze precedenti.
Arrivati a questo punto, non si capisce più allora quale può essere la vera differenza tra inconscio psicoanalitico e inconscio cognitivo, soprattutto se in psicoanalisi aderiamo alla Psicologia dell’Io. In realtà, l’aspetto specifico dell’inconscio cognitivo non è quello implicato nella terapia cognitiva di Beck o Ellis, la cui pratica clinica assomiglia molto a quella certi psicoanalisti contemporanei. Per inconscio cognitivo si intende quella parte del funzionamento mentale che è inconscia non perché è stata rimossa, ma perché non è mai stata conosciuta, e quindi non potrà mai essere ricordata. Non solo, ma non è neppure utile né terapeutico che sia conosciuta, con buona pace di quegli psicoanalisti che volevano perseguire l’ideale di Freud (che derivava dalla sua eredità illuministica) secondo cui “dove c’era l’Es ci sarà l’Io”.
Si può anche dire che l’inconscio propriamente cognitivo sia quella parte di noi “che non si può mai ricordare né dimenticare”, ed è una parte importantissima del nostro funzionamento, indispensabile nella vita quotidiana. Si può anche chiamare “memoria procedurale”, o “elaborazione parallela distribuita” delle informazioni della memoria a lungo termine che regola i movimenti automatici (andare in bicicletta, camminare, ecc.). Noi afferriamo una palla al volo senza essere consci di come facciamo, e se ce lo chiediamo è possibile che non riusciamo più a prenderla così bene (è nota la metafora del millepiedi impazzito, che sa muovere alla perfezione i suoi tanti piedi senza mai inciampare, ma che quando gli viene chiesto come fa risponde che non ci ha mai pensato, e da quel momento non è più capace come prima, attorciglia i suoi mille piedi a ogni tentativo di camminare). Questa memoria è “parallela” perché una caratteristica dei processi inconsci è di non essere “seriali”, cioè non operano uno dopo l’altro ma con infiniti processi che avvengono simultaneamente. La coscienza invece per definizione è seriale, cioè le informazioni passano una dopo l’altra, per così dire in “fila indiana”: questa è una grossa limitazione, nel senso che non possiamo fare consapevolmente due cose nello stesso tempo (ad esempio due discorsi), ma solo una per volta, mentre possiamo conversare con un amico e nello stesso tempo guidare la macchina (poiché la guida, una volta imparata, è automatica, regolata dalla memoria procedurale). Ne consegue che la coscienza opera una selezione tra le tante informazioni presenti nell’inconscio, e questo è il motivo per cui quello che diventa conscio è sempre una parte molto ridotta, limitata, e forse anche distorta, della complessità delle elaborazioni inconsce parallele. Inoltre la coscienza è molto più lenta, funzionando un po’ come un “collo di bottiglia”: occorre più tempo affinché tutta “l’acqua dell’inconscio” esca e divenga conscia.
Va ricordato a questo proposito che quello che esce da questa “bottiglia dell’inconscio” non è mai uguale a quello che vi era contenuto, né si tratta della traduzione dei contenuti che nell’inconscio erano censurati o rappresentati sotto forma di simboli. I due linguaggi, quello dell’inconscio e quello del conscio (che Freud chiamava “processo primario” e “processo secondario”, e che per semplicità potremmo chiamare “non verbale” e “verbale”), non sono facilmente traducibili l’uno nell’altro poiché si tratta di codici cognitivi diversi nella loro natura, nel senso che certe rappresentazioni inconsce non sono esprimibili in parole (si pensi ad esempio alla memoria procedurale che regola il movimento, che non è verbalizzabile). È in questo che l’inconscio cognitivo si differenzia nettamente da quello psicoanalitico, poiché quest’ultimo prevede una traducibilità dei contenuti mentali che erano stati rimossi, per cui può aver senso parlare di un “ritorno del rimosso”. Quello invece che abbiamo definito inconscio cognitivo non è dinamico, ma è semplicemente una modalità di immagazzinamento della memoria a lungo termine, non soggetta a elaborazione verbale.
Ebbene, ci si è resi maggiormente conto è che mentre prima si credeva che questo inconscio procedurale riguardasse essenzialmente l’area del movimento, ora sappiamo che riguarda invece anche i rapporti interpersonali, ad esempio gli stili di attaccamento, che regolano buona parte della nostra vita quotidiana e del funzionamento anche affettivo. Questa maggiore consapevolezza ha messo un po’ in scacco l’ideale psicoanalitico di poter intervenire, soprattutto nei pazienti gravi, col solo strumento della interpretazione. Si pensi alla tecnica psicoanalitica “ortodossa” in cui, per timore della “suggestione”, addirittura si tendeva a deprivare il paziente di ogni componente affettiva, facendo leva sui concetti di anonimità, neutralità, astinenza, schermo opaco, etc., arrivando insomma a quella che Migone ha definito, seguendo la metafora freudiana del chirurgo, “personectomia” dell’analista. Questa tecnica “ortodossa” si rivelò presto poco efficace, e si è riproposta con forza la cura tramite l’esperienza affettiva: si tende sempre più a concepire la psicoanalisi come una tecnica “a tutto campo”, in cui il terapeuta usa la propria persona, e non solo le proprie parole, per indurre il cambiamento nel paziente. La concezione della psicoterapia come in sostanza una “esperienza emozionale correttiva” – usando le parole introdotte da Franz Alexander negli anni 1930-40 – oggi si ripropone con nuovo vigore, anche dopo una maggiore comprensione di quello che abbiamo chiamato inconscio cognitivo.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta
Occorre innanzitutto chiarire cosa si intende per “ricerca” in psicoterapia, in quanto vi possono essere due modi ben diversi per intendere questo termine.
Il primo significato si riferisce alla normale ricerca che fa il clinico coi suoi pazienti, quando cerca di comprendere i significati dei sintomi, fa ipotesi teoriche, e così via; questo tipo di ricerca è quella che fece Sigmund Freud sui suoi casi clinici, e non dimentichiamoci che egli disse che terapia e ricerca sono inscindibili (il famoso Junktim, il “legame inscindibile” tra terapia e ricerca). Il secondo significato si riferisce invece a una ricerca fatta da pochi gruppi di lavoro nel mondo, con strumentazioni sofisticate e metodologie standardizzate (scale di misurazione, registrazione delle sedute, elaborazione statistica, ecc.), molto spesso condotta da ricercatori indipendenti senza la partecipazione del terapeuta (il quale può “inquinare” i dati), e così via; questa ricerca viene chiamata “empirica”, o anche “sperimentale” (il termine “empirica” in realtà è ambiguo, ma è questo il termine che in inglese, per consuetudine, viene usato nella comunità dei ricercatori sperimentali).
Queste due modalità di ricerca possono essere complementari, in quanto la prima può fornire ipotesi preziose per la seconda, che poi le sottopone a verifica. È il secondo significato (quello di ricerca empirica) quello di cui Migone parla in questo seminario.
Il campo della ricerca in psicoterapia assomiglia più a una azienda agricola se paragonato alla ricerca medico-farmacologica che dispone di ricchi finanziamenti. Infatti, pur essendo più costosa, è costretta a basarsi sugli incerti finanziamenti pubblici e su eroici gruppi di lavoro particolarmente motivati. Eppure, anche dietro la spinta di verificare il rapporto costi/benefici da parte delle agenzie governative, negli ultimi anni sono proliferati molti gruppi di ricerca in tutto il mondo.
Innanzitutto chiariamo i termini outcome research e process research, due settori nei quali è consuetudine dividere il campo della ricerca in psicoterapia. Outcome in inglese significa “risultato”, per cui l’outcome research è la ricerca sul risultato della terapia, in termini di differenze tra lo stato pre e post-terapia misurate con scale di valutazione. La process research invece è la ricerca sul “processo” della terapia, condotta anche indipendentemente dal risultato; esempi di process research sono lo studio del rapporto tra alleanza terapeutica in varie fasi della terapia e altre variabili quali sesso o età di entrambi paziente e terapeuta, numero delle sedute, frequenza settimanale, e così via. Questa dicotomia tra risultato e processo non è poi così netta, dato che si tratta di due facce della stessa medaglia nel senso che gli studi sul processo possono rappresentare misurazioni ad interim del risultato, e che comunque si tratta pur sempre di studiare gli “effetti” di determinati comportamenti. La ricerca sul processo poi ha ben poco valore se non viene mai correlata al risultato, per cui può essere giustificato considerare questi due settori come non separati. In determinati periodi storici è stato comunque prevalente un tipo di ricerca sull’altro: come spiega Migone, la ricerca sul risultato ha caratterizzato una prima fase della storia della ricerca in psicoterapia, mentre poi si è passati alla ricerca sul processo.
Più in particolare, possiamo dire che la storia della ricerca in psicoterapia è stata caratterizzata da tre fasi, l’una successiva all’altra anche se parzialmente in sovrapposizione, che possono essere considerate come diverse epoche dello sviluppo culturale in questo settore.
La prima fase domina negli anni 1950-70 (in realtà questa fase fu preceduta da una preistoria della ricerca, caratterizzata dai tentativi di Karl Abraham a Berlino negli anni 1920, di Edward Glover a Londra negli anni 1930, e dagli importanti studi di Carl Rogers in America negli anni 1940). Nella prima fase l’interesse era soprattutto rivolto al risultato della psicoterapia, e le esigenze maggiormente sentite erano quelle del giustificazionismo scientifico e della legittimazione sociale. Il dibattito era dominato dai tentativi di rispondere alla salutare provocazione di Hans Eysenk che nel 1952 aveva sostenuto come non vi fossero prove dell’efficacia di qualsiasi psicoterapia (il suo bersaglio principale però era la psicoanalisi), e dal problema di differenziare il miglioramento dal mero passaggio del tempo, cioè dalla cosiddetta “remissione spontanea” da una parte, e dall’effetto placebo dall’altra (riguardo al concetto di placebo, va ricordato che in psicoterapia, diversamente dalla ricerca farmacologica, non è facile usare il placebo, in quanto si può dire che il placebo sia in se stesso un agente psicologico, e quindi, in senso lato, una forma di “psicoterapia”, per cui al massimo si possono confrontare tra di loro due tipi diversi di psicoterapia). Presto comunque ci si rese conto, anche tramite ricerche pubblicate nel 1980 in cui fu utilizzata la meta-analisi (una tecnica sofisticata che permette di studiare ricerche molto diverse con un unico calcolo), che la psicoterapia di fatto era efficace, ma anche che diversi approcci erano equivalenti. In altre parole, i progetti di ricerca tipo “corsa di cavalli” (horse race) tra varie psicoterapie non riuscivano a determinare nettamente la superiorità di una tecnica rispetto a un’altra. Con una felice espressione di Lester Luborsky, questo fu chiamato “il verdetto di Dodo” (da Alice nel paese delle meraviglie): “Tutti hanno vinto e ognuno deve ricevere un premio”. Questo “paradosso della equivalenza” era una minaccia alla legittimità scientifica delle varie scuole, con l’effetto che ci si rese sempre più conto che lo studio del risultato non era sufficiente.
Si passò dunque alla seconda fase, quella sul processo, che dominò negli anni 1960-80; essa fu scandita da tre conferenze del National Institute of Mental Health (NIMH) degli Stati Uniti dal 1957 al 1966, che sfociarono nel 1968 nella fondazione della Society for Psychotherapy Research (SPR), la associazione che dovrà diventare il principale punto di riferimento per i ricercatori. Qui l’interesse maggiore fu spostato dallo studio del risultato allo studio del processo, nel senso della domanda: “cosa deve succedere nel corso di una terapia per cui ci si può aspettare un risultato positivo?”. In questa fase furono fatti importanti studi: quello della Menninger Foundation di Otto Kernberg, Robert Wallerstein e altri, il Temple Study, lo studio multicentrico dell’NIMH sulla depressione, e così via. Si comprese molto bene come sia illusorio paragonare psicoterapie diverse se non si è sicuri che a ogni psicoterapia chiamata in un certo modo (ad esempio terapia “psicoanalitica”, oppure “cognitiva”) corrisponda la stessa cosa (lo stesso “processo”), per cui in questa fase scoppiò il boom dei cosiddetti “manuali” di psicoterapia. I manuali sono caratterizzati da tre componenti: 1) una selezione rappresentativa dei princìpi di una determinata tecnica; 2) esempi concreti di ogni principio, cosicché non vi siano dubbi su cosa si intende; 3) una serie di scale di valutazione (rating scales) che misurano il grado con cui un campione della terapia (il videoregistrato di alcune sedute scelte a caso) rientra nei princìpi di quella tecnica; queste scale di valutazione sono utilizzabili da chiunque. Come è immaginabile, è quest’ultima caratteristica quella che ha fatto fare un salto di qualità alla metodologia di ricerca, in quanto ha permesso di misurare la concordanza tra un determinato manuale e la tecnica sperimentata. I primi manuali prodotti in ambito psicodinamico sono tre, tutti pubblicati del 1984 e tradotti in italiano: quello di Lester Luborsky per il trattamento “supportivo-espressivo”, quello di Gerald Klerman et al. sulla Psicoterapia Inter-Personale (IPT), e quello di Hans Strupp & Jeffrey Binder per le terapie psicodinamiche brevi.
La terza fase, che inizia negli anni 1970, è quella in cui viviamo oggi. Essa è caratterizzata da un disinteresse sempre maggiore per la ricerca sul risultato e da una intensificazione degli studi sul processo, allo scopo di approfondire i “microprocessi”, cioè capire meglio in cosa consistono quei fenomeni che vengono percepiti come macroprocessi. In questa fase furono compiuti vari studi da Luborsky, che ad esempio dimostrò il potere prognostico della “scala salute-malattia” (Health-Sickness Rating Scale: HSRC) all’inizio della terapia, nel senso che emerse che sono i pazienti “più sani” quelli che ne traggono maggiore vantaggio (con un’altra felice espressione di Luborsky, in psicoterapia “i ricchi diventano più ricchi”); la HSRS, formulata da Luborsky nel 1975, fu poi leggermente modificata e rinominata Global Assessment Scale (GAS) e utilizzata per l’asse V del DSM-III dell’American Psychiatric Association del 1980. Nel complesso, si può dire che in questa terza fase la ricerca in psicoterapia si è consolidata, e una nuova generazione di ricercatori sta avvicendandosi ai pionieri; la SPR ha coagulato un numero sempre maggiore di ricercatori che rompono le barriere delle rispettive scuole per ritrovarsi in interessanti alleanze trasversali; inoltre, anche se con un enorme ritardo (e più che altro costretta dalla crescente crisi della sua immagine sociale), anche la International Psychoanalytic Association (IPA) ha deciso di inaugurare una serie di conferenze annuali con la First IPA Conference on Psychoanalytic Research tenuta a Londra nell’aprile 1991.
Si possono riassumere i risultati ottenuti dalla ricerca in psicoterapia? Non è facile perché è un campo vastissimo, però Migone elenca le principali conquiste della ricerca in psicoterapia così come sono state descritte alcuni anni fa da alcuni autori: gli effetti della psicoterapia superano quelli della remissione spontanea e del “placebo”, che è stato meglio operazionalizzato; i risultati dipendono più dalla persona del terapeuta che dalla tecnica usata; esiste una relativa equivalenza tra terapie; terapie specifiche sono più efficaci per alcuni disturbi; psicofarmaci e psicoterapia sono sinergici; è dimostrata l’importanza del rapporto paziente/terapeuta nel modificare la personalità; possono esservi effetti negativi della psicoterapia (un fatto questo paradossalmente molto positivo, infatti Hans Eysenck si era ben guardato dal dire che era dannosa, altrimenti sarebbe stato costretto a dire che era efficace).
Per un trattamento più approfondito sul tema della ricerca in psicoterapia si può consultare il cap. 11 del libro di Paolo Migone, Terapia psicoanalitica. Seminari, FrancoAngeli, 1995, 2010 e il libro, sempre di Paolo Migone, La terapia psicodinamica è efficace? Il dibattito e le evidenze empiriche, FrancoAngeli, 2021.